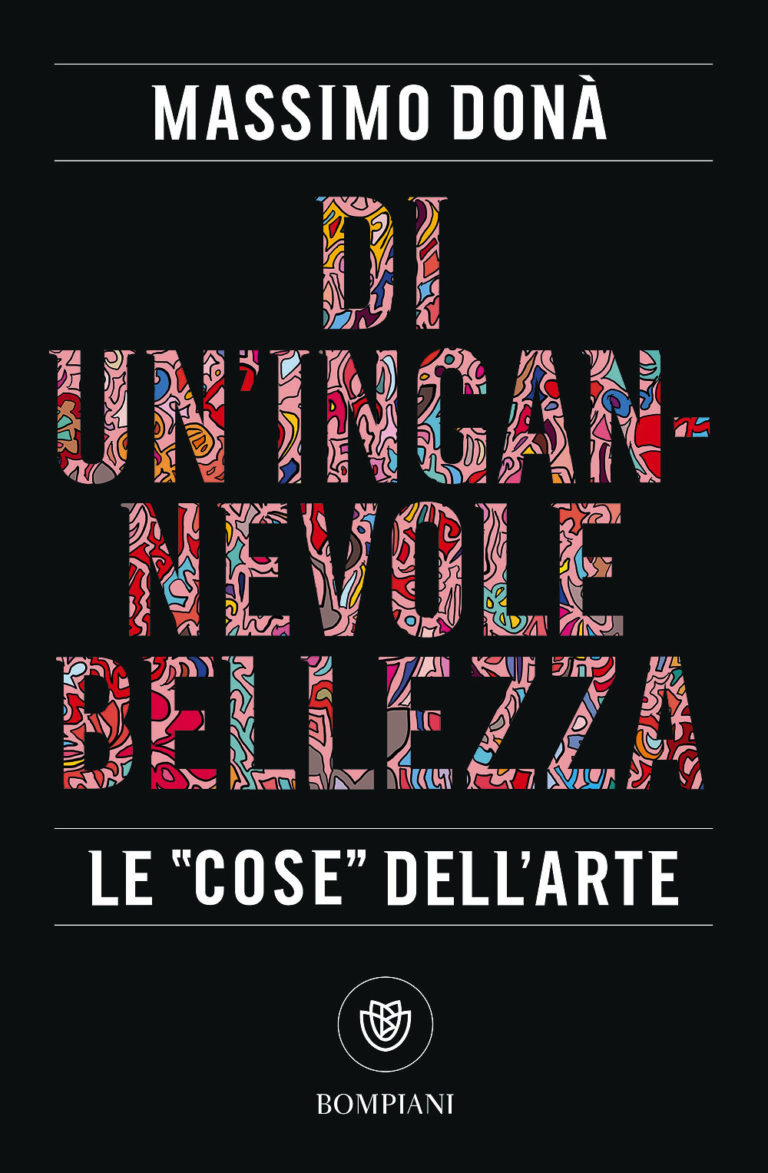Per troppo tempo la filosofia italiana, ancora nella seconda metà del secolo XX, ha patito giudizi ingenerosi indotti dalla vulgata diffusa dalla cultura neo-azionista, stando alla quale, a causa dell’egemonia neo-idealista nella prima metà del secolo ‘breve’, il sapere teoretico del nostro paese sarebbe stato connotato da un tratto provinciale e da marginalità speculativa. In seguito, data la marcia trionfale dell’analitica anglosassone, la speculazione italiana, nonostante qualche nome di prestigio, non sarebbe stata più in grado di colmare il gap d’origine. Non si tratta qui di voler proclamare primati, ma ci pare indubitabile, alla luce del dibattito in corso in tema, che lo schema storiografico esposto, sia infondato e fuorviante. Attorno ai grandi nomi del pensiero italiano del secondo Novecento si sono formate vere e proprie scuole che, sia pur il più delle volte controcorrente rispetto all’indirizzo generale del pensiero europeo, hanno dato ottima prova di sé. Basti qui fare, tra gli altri, i soli nomi di Luigi Pareyson, Emanuele Severino e Massimo Cacciari. Tra i filosofi italiani contemporanei Massimo Donà occupa un posto di rilievo. Egli si è formato dapprima con Severino e, successivamente, con Cacciari, Vitiello e Sini. Sta perseguendo, con coerenza, un percorso teoretico originale e fuori dal coro. Nella sua ultima pubblicazione, Di un’ingannevole bellezza. Le ‘cose’ dell’arte, edita da Bompiani, riapre la discussione sul tema che ha presentato in Teomorfica. Sistema di estetica, uscito nel 2015 per i tipi dello stesso editore milanese.
Donà, lo ha ricordato Mario Perniola nel suo recentissimo, Estetica italiana contemporanea, ha sviluppato una concezione aporetica dell’arte: essa è il luogo dell’enigma e, per questo, può indicare all’uomo contemporaneo un modo di vivere l’aporia che non induce allo scoramento nichilista ma, al contrario, rende capaci di euforia, di ben sopportare la vita. Dei tre topoi estetici attraversati in Teomorfica, solo uno pare essere in grado di garantire, a dire del filosofo, il futuro all’arte e alla bellezza: il topos tomista, i cui esiti novecenteschi sono leggibili, tra gli altri, nelle opere di Marcel Duchamp, René Magritte e Man Ray. Pertanto, i saggi che compongono il libro, proseguono il discorso, già intrapreso, su tale via a partire dal rinvenimento del mistero costituito dalla bellezza.
La bellezza ci pone di fronte alla sacralità delle cose, al loro non essere riducibili alla dimensione di mezzi-per, legati a significati e finalità date. Ogni oggetto bello è, innanzitutto, semplicemente colto nella sua dimensione di esistente, di presenza. In ogni espressione della bellezza si palesa quella struttura che Tommaso riteneva esser propria di Dio. Ciò vuol dire che ogni cosa, se dotata di bellezza, sarà cosa e insieme Dio, particolare e universale, essere e nulla. La bellezza si configura per Donà essenzialmente come inganno: essa è sempre doppia e ambigua. Il pensatore veneziano rileva come nell’arte i distinti riescano ad esibire il loro non essere affatto distinti. Ne ebbero contezza Novalis e Breton: entrambi consapevoli che il furore ermetico-alchemico aveva permesso
di sciogliere le morte contrapposizioni, di sciogliere, cioè, il metallo vile […] e farlo diventare per una vera e propria alchimia del verbo […] oro puro.
Il furor divampa anche nella creazione artistica. Arte come magia finalizzata a smuovere il noto, il de-finito, figlio del dominio del logos, al fine di alludere allo sfondo magico-poetico del mondo. Per Novalis l’uomo è in rapporto con le parti costitutive dell’universo: sta alla nostra attenzione indirizzarci verso l’una o l’altra, far prevalere un rapporto dato. Eros è fuoco che alimenta le azioni magiche, pertanto l’arte era, in illo tempore, espressione chiarissima del fare magico. La ratio calcolante ci impedisce di averne piena coscienza. L’immaginazione non è, come Kant avrebbe voluto, semplice facoltà, ma forza incondizionata che ci congiunge simpateticamente al tutto.
Lo comprese nella sua disputa animico-tellurica contro lo spirito logocentrico, il cosmico monacense Ludwig Klages:
Il fondamento […] può rivelarsi solo là dove la coltre categoriale familiare all’intelletto sappia accoglierlo dismettendo l’habitus che, solo, sembra in grado di garantire risultati solidi e ben fondati.
L’arte autentica, come la magia, ci dice di un’opposizione assoluta vivente in ogni cosa, ci dice di un’ impossibile che, facendo, genera un limitato quale presenza dell’illimitato. Nel Seicento, in pieno Barocco, ne ebbe sentore Giambattista Basile con il suo Lo cunto de li cunti. Nei suoi quarantanove racconti si susseguono alterazioni della catena causale, che rendono possibile l’esplicarsi del mondo alla rovescia. Esso ha i tratti di uno specchio deformante che, in realtà, è profonda descrittiva della vita, del suo mistero, molto più di quanto lo sia qualsiasi resoconto di fatti reali. La fiaba ed il racconto fantastico risultano massimamente ‘veri’ in misura inversamente proporzionale alla loro plausibilità.
Il fantastico delucida la flebile distanza che distingue l’esperienza dalla fantasia, dicendo come il noto contenga sempre l’ignoto. Il Barocco e il fiabesco, per Donà, invitano a rovesciare il quadro sistematico approntato da Platone e da buona parte della filosofia classica. Nel Seicento, nella letteratura del secolo d’oro, nel Don Chisciotte torna a darsi ciò che Bruno già sapeva: è la natura ‘individuale’ a mostrare il sigillo divino. Il cavaliere dalla trista figura, emblema per antonomasia del sapere altro, non poteva che essere ‘malinconico’ (nel senso attribuito alla malinconia da Dürer). Egli era incapace di accettare le inderogabili ed apodittiche leggi che dominano la vita. Nato nell’età del ferro, il suo agire tendeva a ripristinare l’età dell’oro. In considerazione di ciò l’importante è che la spirale dell’azione non trovi mai ‘un fine’, e neppure una fine.
Tale visione è presente nel teatro di Shakespeare, nel Sogno d’una notte di mezza estate e nella Tempesta. Il bosco diviene l’ambientazione prediletta di azioni insensate, folli, non-logiche o, comunque, attestanti un’altra logica. Del resto, nei racconti mitici di tutti i popoli, il bosco dà ricovero alle passioni amorose e alla cerca del Sé. Non è casuale che tale paesaggio d’anima abbia attratto il trascendentalista Emerson e il suo discepolo Thoreau, che nelle foreste nord-americane visse al fine di dimostrare che ognuno può farsi protagonista di un’esperienza realmente unica e irripetibile e che non vi sono modelli. Il bosco è al centro della narrativa di Buzzati, tanto nel Segreto di bosco vecchio quanto in Barnabo delle montagne. Nello scrittore bellunese, l’ambiente boschivo e montano diviene luogo di possibili iniziazioni, oltre il dominio della coerenza e del progresso, fondati entrambi sull’ideale dell’efficacia. Per Buzzati il mistero è sempre davanti ai nostri occhi. Così, la goccia d’acqua, protagonista di un suo bellissimo racconto, sale i gradini di una scala, testimoniando l’esistenza di fatti naturali che non si comportano in quanto tali. La goccia dice l’irruzione di una dimensione ignota nel mondo regolare dei fenomeni fisici. Lo scrittore porta alla luce, come in ogni arte autentica, il tratto inconcettualizzabile del reale, già annunciato nella Tempesta di Shakespeare. In essa nulla, a cominciare dalla tempesta iniziale, è ciò che sembra essere, domina l’incantesimo e la metamorfosi di ogni cosa mostra che ogni ente è manifestazione del ni-ente.
La custodia del nulla di ente, del ni-ente, dell’origine, è affidata alla bellezza, questa la sua meraviglia, come rammentano le mirabolanti avventure di Alice pensate da Carroll e discusse magistralmente da Donà. La bellezza è libertà e, proprio in funzione di ciò, richiede il coraggio dell’azzardo, dell’euforia e della serena sopportazione. L’esperienza estetica ri-propone, per queste ragioni, nella contemporaneità, la medesima interrogazione originaria della filosofia, in quanto determinantisi come modi dell’unico possibile inizio di ogni discorso che, in quanto veritativo, sarà destinato ad un’infinita erranza.
In tale modalità, l’arte potrà tornare a mostrare l’eccedenza del reale, e sarà allora davvero, per usare le parole di Gianni Carchia, altro grande teoreta italiano di cui poco si discute, ‘arte della filosofia’. Il danzatore è figura paradigmatica dell’arte della filosofia. Questi è simile a Talete, protofilosofo che, per guardar le stelle, cadde in un pozzo, irriso da una servetta tracia. Il milesio, mirando all’alto, nel precipitare rimase senza respiro e, per un attimo, senza pensiero, pervaso, come ha rilevato di recente Romano Gasparotti, da un sentimento, a partire dal quale il pensiero può rinascere e rigenerarsi.
Giovanni Sessa-L’intellettuale dissidente