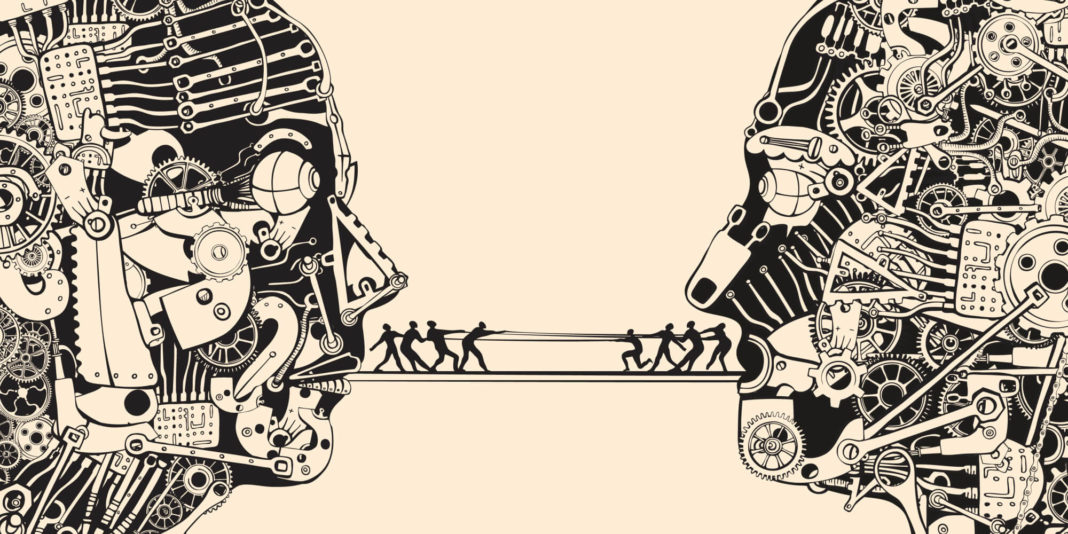Il QI (Quoziente Intellettivo) medio della popolazione mondiale, che dal dopoguerra alla fine degli anni ’90 era sempre aumentato, nell’ultimo ventennio è invece in diminuzione. È l’inversione dell’effetto Flynn.
Sembra che il livello d’intelligenza misurato dai test diminuisca nei paesi più sviluppati. Molte possono essere le cause di questo fenomeno. Una di queste potrebbe essere l’impoverimento del linguaggio.
Diversi studi dimostrano infatti la correlazione tra la diminuzione della conoscenza lessicale e l’impoverimento della lingua: non si tratta solo della riduzione del vocabolario utilizzato, ma anche delle sottigliezze linguistiche che permettono di elaborare e formulare un pensiero complesso.
La graduale scomparsa dei tempi (congiuntivo, imperfetto, forme composte del futuro, participio passato) dà luogo a un pensiero quasi sempre al presente, limitato al momento: incapace di proiezioni nel tempo. La semplificazione dei tutorial, la scomparsa delle maiuscole e della punteggiatura sono esempi di “colpi mortali” alla precisione e alla varietà dell’espressione.
Solo un esempio: eliminare la parola “signorina” (ormai desueta) non vuol dire solo rinunciare all’estetica di una parola, ma anche promuovere involontariamente l’idea che tra una bambina e una donna non ci siano fasi intermedie. Meno parole e meno verbi coniugati implicano meno capacità di esprimere le emozioni e meno possibilità di elaborare un pensiero.
Gli studi hanno dimostrato come parte della violenza nella sfera pubblica e privata derivi direttamente dall’incapacità di descrivere le proprie emozioni attraverso le parole. Senza parole per costruire un ragionamento, il pensiero complesso è reso impossibile. Più povero è il linguaggio, più il pensiero scompare.
La storia è ricca di esempi e molti libri (Georges Orwell – 1984; Ray Bradbury – Fahrenheit 451) hanno raccontato come tutti i regimi totalitari hanno sempre ostacolato il pensiero, attraverso una riduzione del numero e del senso delle parole.
Come l’impoverimento del nostro linguaggio e del nostro pensiero sia subordinato a precise esigenze politico-economiche, è messo in luce da un famoso linguista contemporaneo Uwe Pörksen che ha elaborato il concetto delle ‘parole di plastica’. Nel suo testo “Parole di plastica – La neolingua di una dittatura internazionale“, evidenzia la degenerazione del linguaggio nelle società industrializzate della seconda metà del Novecento. Pörksen nota che alcuni termini (le parole di plastica o parole-ameba) sono entrati a far parte del linguaggio comune, perdendo il loro significato denotativo e acquisendo una grande varietà di connotazioni. (Ricordiamo che ogni vocabolo si caratterizza per la sua denotazione, cioè il significato esplicito di ciò a cui si riferisce e per la sua connotazione, ovvero il significato implicito determinato dalla sua carica emotiva.
La denotazione è quindi un concetto relativamente stabile sul quale tutti i parlanti sono d’accordo, mentre la connotazione può variare a seconda del contesto, della persona, della cultura, della situazione in cui il vocabolo viene usato). Un’immagine efficace della differenza tra denotazione di una parola e connotazioni ad essa associabili l’ha data la linguista Beatriz Garza, che paragona la denotazione, ovvero la designazione della cosa, alla prima onda che si forma quando si getta un sasso nell’acqua e la connotazione, che designa le sensazioni, le valutazioni, le associazioni inerenti alla cosa, a tutte le onde successive. Secondo Pörksen, le parole di plastica “sembrano consistere solo nelle connotazioni che si allargano in cerchi concentrici, mentre il sasso e la prima onda sono scomparsi.”
Proprio per questa mancanza di una denotazione precisa, le parole di plastica costituiscono – a suo parere- una “neolingua”, di orwelliana memoria, funzionale al potere e che impedisce la formazione di un pensiero critico, dato che sono intercambiabili e con esse si possono creare frasi che sembrano avere un senso, ma non ne hanno nessuno. Ma quali sono le parole di plastica? Ecco alcuni esempi: “sviluppo, sessualità, relazione, comunicazione, bisogno fondamentale, ruolo, informazione, produzione, materia prima, risorsa, consumo, energia, lavoro, partner, decisione, management, service (servizi), assistenza, educazione, progresso, problema, pianificazione, soluzione, funzione, fattore, sistema, struttura, strategia, capitalizzazione, contatto, sostanza, identità, crescita, welfare, trend, modello, tenore di vita, modernizzazione, processo, progetto, centro, futuro”. Possono sembrare parole innocue, ma vengono usate più e più volte da esperti – politici, professori, funzionari aziendali e pianificatori – per spiegare e giustificare i loro piani e progetti ottenendo un consenso collettivo, senza che il senso reale dei loro discorsi sia chiaro.
Se non esistono pensieri, non esistono pensieri critici. E non c’è pensiero senza parole. Come si può costruire un pensiero ipotetico-deduttivo senza il condizionale? Come si può prendere in considerazione il futuro senza una coniugazione al futuro? Come è possibile catturare una temporalità, una successione di elementi nel tempo, siano essi passati o futuri – e la loro durata relativa – senza una lingua che distingue tra: ciò che avrebbe potuto essere; ciò che è stato; ciò che è; ciò che potrebbe essere; ciò che sarà dopo che; ciò che sarebbe potuto accadere è realmente accaduto?
Cari genitori e insegnanti: facciamo parlare, leggere e scrivere i nostri figli, i nostri studenti. Insegnare e praticare la lingua nelle sue forme più diverse. Anche se sembra complicata. Soprattutto se è complicata.
Perché in questo sforzo c’è la libertà.
Coloro che affermano la necessità di semplificare l’ortografia, scontare la lingua dei suoi “difetti”, abolire i generi, i tempi, le sfumature, tutto ciò che crea complessità, sono i veri artefici dell’impoverimento della mente umana.
Non c’è libertà senza necessità. Non c’è bellezza senza il pensiero della bellezza.
Fonte