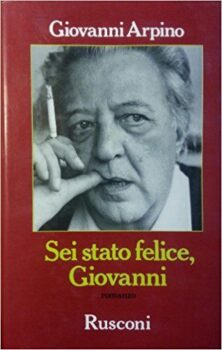Appena si termina la lettura di Sei stato felice, Giovanni, romanzo del 1952 di Giovanni Arpino, di colpo si potrebbe avvertire con forza la necessità di piangere, sentendosi subito dopo più leggeri. Tale reazione per alcuni può risultare abbastanza inconsueta, soprattutto se il libro in questione non è un testo romantico, né drammatico, semmai un’opera neorealista, avventurosa, scritta con disinvoltura e leggerezza, che conduce ad un possibile felicità la quale giustifica il pianto precedente.
Il romanzo di Arpino era in netta contrapposizione con lo stile serio della maggior parte dei romanzi italiani del dopoguerra.
Nel 1950 Giovanni Arpino ha appena 23 anni quando decide di scappare da Torino per approdare a Genova, dove prendendo alloggio in una lurida e sporca pensione, mangiando male ed il minimo indispensabile, in venti giorni partorisce la sua opera prima, per l’appunto “Sei stato felice, Giovanni”. Ricopia in fretta e furia il manoscritto a macchina e lo invia all’Einaudi, dove Italo Calvino non ne è convinto del tutto, ma grazie ad Elio Vittorini, per il quale il romanzo è da stampare “senza esitazioni” il romanzo vedrà la luce.
È proprio a Genova che Arpino decide di ambientare questo romanzo, facendo aggirare Giovanni, il protagonista, ed i suoi due amici Mangiabuchi e Mario, per i suoi vicoli ed il porto, mostrandoci e conducendoci per mano in una città che cerca faticosamente di rialzarsi dai danni della guerra.
Dei tre, Giovanni, è l’unico ad amare la lettura, e fa i salti mortali per avere la propria indipendenza, per vivere in una camera di un povero albergo e potersi ritagliare i propri spazi per leggere. Nonostante sia circondato dalla povertà, da compagnie non di certo illuminanti, e cerchi di vivere alla giornata cercando in continuazione trucchi per sopravvivere, i libri rimangono quella perenne finestra aperta verso la felicità, da lui tanto agognata.
Sono il suo rifugio sicuro che gli permette di poter gridare al mondo la sua diversità da chi, come ci dice riferendosi a Mangiabuchi: “Non sapeva né pensare né non pensare, vivere giorni seduto su uno scalino, solo mangiare e dormire sapeva e neanche bene”.
Se a Giovanni gli avessero sottratto il suo sentirsi diverso, estraneo da tutti, probabilmente non gli sarebbe rimasto più nulla. È la sua unica ancora, alla quale si appiglia con forza fin dalle prime battute. Sono intrise di visioni del futuro queste pagine, colme di paura per quel che sarà e ci sarà, e ci si rende conto facilmente con l’avanzare delle pagine di quanto sia cambiato essenzialmente poco da quel che dovevano provare i giovani nel dopoguerra, dove vi erano mille incertezze e incognite, alla sensazione di spaesamento e solitudine che si ha oggi, nel 2022. Si è tramandata quella perenne sensazione di vagabondaggio del destino, che non volendosi definire o delinearsi naturalmente davanti ai nostri occhi man mano che si cresce, ci fa girovagare senza meta, spaesati, cercando forsennatamente di raggiungerlo.
In ogni epoca, i giovani hanno sempre avuto problemi. Dopotutto sono i nuovi, gli appena arrivati, e come tali devono adattarsi ad un mondo già avviato, lanciato a tutta velocità su binari ben collaudati, e l’adattamento in qualsiasi ambito lo si faccia, non è mai facile. Esser giovani per Arpino è sinonimo di libertà, di notti insonni, di assenza di legami, vuol dire svegliarsi a sonno finito, andare al porto e camminare. Significa pensare in continuazione a come dare una svolta alla propria esistenza, trovare un lavoro che appaghi, che faccia fare una barca di soldi, ma al contempo non averne neanche più di tanto voglia, perché le giornate scorrono troppo in fretta e si ha anche voglia di trastullarsi,
bere, fumare, leggere.
Giovanni non è felice, ed il motivo è semplice, non è soddisfatto di quel che fa e mentre i suoi amici si accontentano di sopravvivere, saltando di giorno in giorno da un lavoro occasionale all’altro, lui soffre e si vede immobile, perché in cuor suo pensa di meritar di più. Quindi non appena si siede ad un bar per bere una birra, sente d’aver appena soddisfatto un bisogno, quello della pigrizia, della nullafacenza, è sereno lì seduto a guardare il mondo che gli scorre di fianco, ma non trascorre molto tempo prima che gridi disperatamente tutta la sua insoddisfazione e voglia di cambiare: “Venir fuori e mettersi per le strade a fare qualcosa, qualsiasi cosa per cui un uomo è un uomo e non solo una mano che dipinge cassette. Ero stato un mucchio di cose, mai un uomo che comincia a muoversi davvero.”
Le prova tutte Giovanni per essere felice, finché stremato nell’ultima parte del romanzo si arrende, e fissando il busto di un poeta che incontra passeggiando, gli parla guardandolo in faccia, senza timori, sfrontato, tirando fuori parole pesanti come mattoni, lasciandole lì ai suoi piedi. Quasi a togliersi un peso, che non gli permetteva più di muoversi.
“Io so solo che sono stato felice e che darei l’anima per poterlo essere ancora un poco. Sicuro, sono stato felice, ma non basta. Non basta mai”. Giovanni vuole andarsene da Genova, e lo fa, prendendo un treno direzione Roma e riponendo tutto quel che ha nella speranza.
La speranza che tutto quel che avrebbe avuto nella capitale sarebbe stato lontano anni luce da quel che aveva avuto fino al giorno prima. Voleva scordarsi della fame, dei debiti, dell’indefinito.
Non dorme in treno, non ci riesce, la speranza è troppa.
Grazie a Giovanni, si può riuscire ad esser felici.