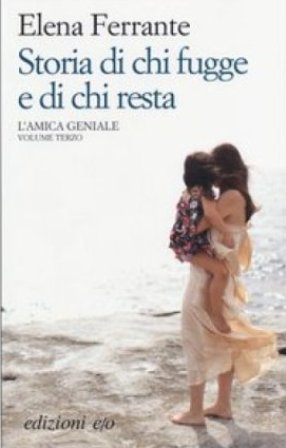Elena Ferrante è diventata un vero e proprio caso letterario. La critica d’Oltreoceano l’ha accolta con parole entusiaste e un grande interesse aleggia anche intorno alla stessa identità dell’autrice.
Elena Ferrante è infatti uno pseudonimo che cela, a detta di alcune indiscrezioni, non altro che Domenico Starnone. Tuttavia al di là di questa parentesi da gossip, il plauso resta meritato e le vendite lo confermano, non accadeva da illo tempore. Leggere Storia di chi fugge e di chi resta (terzo volume di una quadrilogia intitolata L’Amica Geniale) fa tirare un gran sospiro di soddisfazione e si ha l’impressione di avere tra le mani, finalmente, un romanzo all’altezza della migliore tradizione italiana in prosa. Un capolavoro che non strizza l’occhio alle mode letterarie del momento o ci proponga la solita storia messa ben a punto da un bravo editor e da una strategia di marketing destinati solo ed esclusivamente a vendere e a far parlare di sé.
L’avvincente discussione sull’identità della scrittrice, per quanto aggiunga un po’ di pepe, rischia di sminuire la portata di quello che ha scritto, declassandolo a oggetto da salotto massmediatico, senza riconoscere che questa autrice ha elevato nuovamente ad alto rango il Romanzo.
Chiunque lo abbia scritto, Storia di chi fugge e di chi resta, non è solo un bellissimo romanzo ma un punto di svolta nella letteratura contemporanea italiana. Elena Ferrante è riuscita laddove già molti altri autori si sono cimentati con scarsi esiti, ovvero scrivere l’autobiografia di una generazione e di un preciso momento storico segnato dal comunismo e dal femminismo. Il livello della microstruttura investe temi più controversi e avvincenti quali il progresso, la mobilità sociale, la speranza in un riscatto sociale affidato alle proprie capacità.
L’intelligenza, infatti, è l’unica arma di cui le protagoniste dispongono. Nate nella miseria dei rioni popolari di Napoli, Lenù e Lila tentano di cambiare le proprie vite ma adoperano i rispettivi capitali cognitivi in modo dicotomico. Lenù rispettando tutte le regole e Lila non rispettandone neanche una. Eppure anche lei, pur nei limiti del quartiere, riesce a realizzarsi nel settore dell’informatica. Lenù parte, fugge. Lila resta e prova dall’interno e con il suo carisma ad opporsi alle regole eterne delle strade di Napoli. Tuttavia finiscono entrambe sconfitte se le si rapporta al mondo che non cambia e il riscatto delle loro esistenze risulta vano.
Insomma il romanzo, popolato da personaggi le cui vite si intrecciano slegano e ricompongono, è il manifesto di una grande sconfitta collettiva. Perdono tutti: chi la vita, chi la libertà. Gli amici cresciuti con le due protagoniste seguono la medesima parabola discendente: sconfitti quelli hanno fatto carriera con il Psi di Craxi, quelli che sono ascesi con la camorra, quelli che hanno sperato in una rivoluzione. Elena Ferrante non si limita a narrare una storia privata ma intesse il romanzo epico di un pezzo di storia, la nostra, quella italiana, del boom economico e delle sue contraddizioni. La scrittrice racconta un ‘68 filtrato dall’esperienza di personaggi tutti italiani. E allora è possibile constatare quanto in quei fantastici anni, in cui tutto sembrava possibile, da L’immaginazione al potere a Il sesso è politico, qualcosa in Italia si è inceppato e ha interrotto il cammino della nostra storia, tanto da far scrivere la carta stampata di un ‘caso italiano’. Un caso che non è quello, o non solo, delle grandi città del Nord ma anche del Sud, di coloro che borghesi non lo erano affatto e se intentavano una ‘lotta di classe’, dovevano affrontarla in primis tra le mura domestiche, poi nel quartiere sino alla fabbrica.
Il lavoro di Elena Ferrante è un romanzo popolare ma immenso poiché restituisce, attraverso personaggi frastagliati, la complessità dell’Uomo. Risulta difficile parteggiare pienamente per ciascuno di essi, così come è impossibile definire a pieno titolo i Buoni e i Cattivi. Resta su di essi un cono d’ombra che lascia indefiniti alcuni interrogativi, ogni volto che il lettore incontra è un mondo a sé e pertanto ogni ontologia resta irrisolta.
Elena Ferrante è riuscita dove tanti hanno fallito perché “Scrive”, perché sa coniugare la testa e le viscere come a pochi è concesso dal talento e forse anche per la volontà di ripercorre una parabola esistenziale dal basso. Il punto di osservazione appartiene a coloro i quali l’ascensore sociale non era una definizione sociologica ma il confine tra la vita e la sopravvivenza. E perché non la mette mai al centro della narrazione, ma la rilegge attraverso il prisma emotivo di un’amicizia al femminile. Amicizia strana, peraltro, con una simmetria troppo perfetta tra le due biografie così perfettamente opposte, una il rovescio esatto dell’altra. Due amiche, legate dal rapporto più intimo della loro vita ma forse anche due parti della stessa identità.
Ma Elena Ferrante è una narratrice e rifugge da intenti pseudo pedagogici e si astiene dall’azzardo narcisistico di fornire una qualche spiegazione. In Storia di chi fugge e di chi resta, l’autrice ha raccontato e descritto una vita, un’amicizia, un’epoca storica, una generazione e la sua catastrofe. Andare oltre e trovare una spiegazione di senso sta a chi legge, perché questo è quello che si fa con i grandi libri.