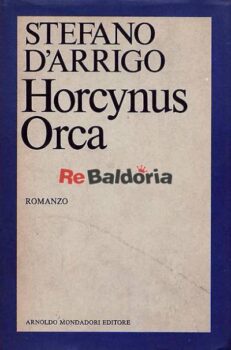Soltanto dopo aver letto e riletto Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, romanzo sfrontato, inizialmente rifiutato dall’editoria, il quale getta un ponte nientemeno che tra Storia e Mito, si scopre che anche George Steiner, si era confrontato con l’ambiziosa lingua che – durante le letture che il professor Frasnedi era solito fare ai suoi studenti – mi aveva fatalmente colpito. Poche parole di Steiner, in un articolo apparso sul Corriere della Sera, descrivono l’emozione della lettura e dell’incontro-confronto con una lingua che ha un’intonazione nuova e riconoscibile e che, anche a me, sembrò fin da subito aver qualcosa da dire:
[…] mi trovai, matita in mano, a leggere e rileggere la stessa pagina nello sforzo di capire; consapevole che molto di quel che c’ era scritto mi sarebbe rimasto oscuro. Non importa. Il moto oceanico della storia, il fantastico potere dell’intreccio di motivi arcaici mitologici e della feroce realtà della Seconda Guerra Mondiale, la capacità di D’Arrigo di dare una vita violenta e lirica agli elementi del tempo e del paesaggio, del mare e della terra, mi fecero superare ogni barriera linguistica e grammaticale.
I procedimenti sintattici e retorici, le “riscritture interne” che caratterizzano lo stile di Horcynus Orca, hanno spesso la funzione di «stabilire un contatto privilegiato col lettore».
Horcynus Orca “non ha un principio, uno svolgimento, una conclusione. E’ un continuo divenire, un costante andare, un eterno ritorno. Parole, idee, ricordi, suoni, immagini, fantasie, colori, sapori, dolori, passioni sono tutti là dentro, in quella profonda gola narrativa che è “L’Orca”. La storia personale di Stefano D’Arrigo é strettamente intrecciata con quella del suo poema epico moderno, Horcynus Orca, appunto. Un lavoro che ha impegnato l’autore siciliano per quasi vent’anni in continue riscritture e aggiunte, invenzioni stilistiche e lessicali, rimandi all’epica classica e alle nuove tecniche di scrittura del ‘900. Un impegno costante che ha contribuito a trasformare “I fatti della fera” (questo il titolo originario) in un mitico ed epico poema della metamorfosi, facendo del libro la risposta europea a Moby Dick di Melville.
‘Ndrìa Cambrìa, dopo l’8 settembre del ’43, è un marinaio della fu Marina Regia che, sbandato, intraprende il viaggio di ritorno a casa da Napoli a Cariddi sulla punta siciliana dello Stretto di Messina. È il classico viaggio di ritorno dell’eroe dalla guerra: l’evidente riferimento immediato è l’Ulisse omerico, letto però con la lente distorcente dell’Ulysses joyciano.
L’eroe di D’Arrigo ritrova un mondo devastato materialmente e spiritualmente, definitivamente altro rispetto a quello che aveva lasciato; un mondo nuovo, allucinato e orribile che gli si manifesta per “arcana e enimmata”: gli incontri, i discorsi che si sente fare, i fatti cui assiste e partecipa non sono più inquadrabili dentro le coordinate esistenziali che l’avevano visto crescere e farsi uomo, ma devo essere rivisti nella penombra di nuove coordinate che stentano, però, ad apparire, a farsi chiare. Ma in quanto eroe ‘Ndrìa non si rassegna, soffre e lotta per far rivivere il mondo com’era, si oppone ostinatamente a quello nuovo e sconosciuto, vorrebbe fare della Storia una parentesi vinta e reinglobata nel Mito. Un eroe che l’autore, già al di là di quella storia, già conscio dell’irrimediabile trasformazione, vota alla sconfitta.
Horcynus Orca é una lettura che manifesta l’immensa ricchezza tematica con cui D’Arrigo ha voluto caratterizzare la sua opera. Le scelte lessicali misteriose, i parallelismi tra i suoi personaggi e quelli dei grandi poemi epici, come l‘Odissea e l’Eneide, l’Orca vista come simbolo accostabile al Leviatano, sono tutti elementi che affascinano e sfidano il lettore, invitandolo ad avventurarsi nella grandiosa costruzione su cui D’Arrigo ha trascorso una vita.
Il lettore è guidato ad apprendere una nuova lingua, a coglierne il senso rispondendo attivamente al testo. Per capire come il percorso della scrittura renda comprensibile e arricchisca le potenzialità significanti del lessico confrontiamo FF e HO riguardo alla prima
occorrenza di tangeloso. In HO si nota un rafforzamento del sistema di riscritture e glosse interne al testo:
[Cata] Se ne stava in un’aria queta ma delicata, e in quest’aria tutta tangelosa appariva contornata da una maestosità senza ragione e senza forza
[Cata] Se ne stava là, posata più che seduta sul bordo della cofana, fra le due vecchie all’impiedi, tutte in muti riguardi, sola con quel suo sorriso strano, terribile, beato: in un’aria delicata, in vetrina, come qualcosa di intoccabile dietro un vetro, in un’aria tutta tangelosa, dove appariva contornata da una maestosità senza ragione e senza forza.
Il significato di tangelosa è orientato dal cotesto. In HO si può vedere come l’espressione venga levigata per focalizzare con più precisione il complemento di luogo e l’aggettivo che potrebbe dare il senso di tutta la scena. I due punti hanno il ruolo di scandire il ritmo. Prima è stabilita un’ambientazione, subito inscritta nell’evidenza dell’avverbio di luogo cataforico, e poi dispiegata nei dettagli nei cola seguenti.
Poi, la scrittura si fa più impressionistica, cerca di cogliere il senso che si cela appena sotto l’evidenza del reale. Rispetto a FF, in HO viene isolato questo momento, ed evidenziata la dimensione indugiante, in cui per approssimazioni successive si giunge all’«aria tutta
tangelosa».
Questo indugiare è l’effetto della sintassi giustappositiva, con i complementi che si accumulano (con una disposizione a chiasmo delle ripetizioni: in un’aria delicatavetro-vetrina-in un’aria tangelosa) e conducono il lettore a interpretare l’aggettivo in base al cotesto. L’interpretazione rimarrà sicuramente nello spazio dell’incertezza, ma la comprensibilità è assicurata. Nelle successive occorrenze98 del termine non ci sarà più bisogno di “inquadrarlo”, e allo stesso tempo queste occorrenze saranno altrettanti inviti a rielaborarlo ed acquisirlo nella lingua della lettura.
Horcynus Orca si potrebbe forse intendere come un rimpianto per la scomparsa dei dialetti e delle modalità di conoscenza e di vita ad essi associati. L’allentarsi del legame tra il nome e la cosa, la scoperta di un mondo e di una lingua in cui “la fera non è fera”, permette l’intrusione del nome italiano del delfino nel codice linguistico di ‘Ndrja; il nuovo nome dà il via ad un riassestamento cognitivo, una rotazione reciproca dei nomi intorno alla cosa in sé, che non ha più un senso univoco.
Si può dire che sia tipico di Horcynus Orca creare “spirali linguistiche” che tentano di conferire senso al lessico attraverso una paziente messa a fuoco; d’altra parte la “profondità di campo” lascia scorgere la rete di relazioni che collega il primo piano allo sfondo, cioè che conferisce senso ai singoli elementi inscrivendoli nel sistema linguistico complesso del romanzo. In questo sistema al nome fera sono collegate, come si è visto, aree semantiche e attributi relativi alla malignità e alla finzione.
Come ebbe a dire Giuseppe Pontiggia: “‘Horcynus Orca’ è un mitico e epico poema della metamorfosi. La concezione del mondo come metamorfosi affonda le sue radici nella religiosità mediterranea… Per questo D’Arrigo ha potuto creare un epos moderno, riprendendo, come Joyce nell’Ulisse, un tema mitico: perché in un’età in cui il mito dominante è quello di dissolvere i miti arcaici, solo la tragedia incommensurabile della loro perdita può essere il tema della tragedia”.
L’opera di D’Arrigo, che rappresenta un universo personalissimo e autosufficiente, dove si indossa ma maschera per proferire la Verità, può essere letta secondo le più diverse chiavi di lettura, simboliche, allegoriche, sociali, politiche, ma che è prima di tutto un grandioso progetto letterario, una sorta di “riesumo” dell’epica rivissuta come approccio letterario al mondo. Quella di D’Arrigo è un’epica orientata verso il nero della morte, e talvolta sembra perdere quell’equilibrio, quella compresenza tra fatalità tragica e rinascita vitale che è una delle peculiarità del movimento epico. È un’epica nella quale il Mito è come ucciso dalla guerra, dalla Storia.
Poteva calarsi a Scilla, per dire, e da l“dirigere, visav“ o quasi con la rocca scillota, a Cariddi, anche se questo significava bordeggiare per tutta la sua lunghezza, dicinque miglia all’incirca, la linea dei duemariò.