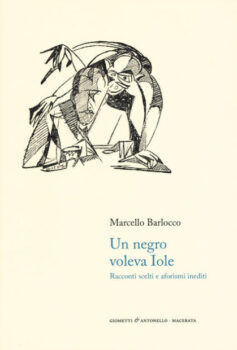Oltre a scoprire nuove voci, letterarie e non, fare editoria dovrebbe significare anche provare a recuperare quelle provenienti dal passato che, per un motivo o l’altro, non sono note o vengono dimenticate. In questo, la Giometti&Antonello – piccola casa editrice di Macerata, creata da Gino Giometti e dal compianto Danni Antonello – continua a riservarci piacevoli sorprese, come Un negro voleva Iole, libro che presenta una selezione di racconti, editi ma rimasti ignoti ai più e aforismi, totalmente inediti, di Marcello Barlocco (1910-1972), scrittore dall’esistenza tumultuosa e che, in vita, è sempre rimasto ai margini della letteratura italiana, come si ricorda nella nota degli editori.
Poi, in tempi più vicini a noi, qualcosa è riaffiorato, ma sempre molto poco: un ricordo di Carmelo Bene, incluso nella sua biografia (1998); la ristampa di un romanzo breve dell’autore, Veronica, i gaspi e Monsignore, pubblicato da Greco&Greco e con l’utilissima curatela di Andrea Marcheselli (2005).
LA GRAN PARTE di Un negro voleva Iole ha come fonte I racconti del Babbuino, libro uscito nel 1950 e che ebbe una menzione al Premio Viareggio di quell’anno.
Dei testi in questione, ce ne sono due inclusi nelle loro versioni successive, Le mani e L’amante delle parabole. Del primo circola anche in rete una registrazione audio della sua lettura da parte dell’autore stesso; del secondo invece sappiamo che si tratta di una versione pubblicata per una rivista dell’epoca. E sempre per quella stessa rivista – Il delatore -, Barlocco pubblicò Un’avventura a Genova, storia non presente nel volume originario e che, con il titolo La formula, si può leggere nel volume stampato dalla Giometti&Antonello.
Ora, al di là dell’innegabile piacere del testo – la lingua usata è al servizio delle singole narrazioni, ma non mancano sottigliezze stilistiche che impreziosiscono gli orditi -, come definire la letteratura di Barlocco? Qui non si può che concordare con Daniele Giglioli, che nella puntata dedicata al libro del programma di Radio3 Fahrenheit, lo scorso 12 febbraio, riconosce la difficoltà dell’operazione, sottolineando il fatto che risulterebbe erroneo associare le fantasie dello scrittore a quelle di autori come Buzzati, Landolfi, Tozzi.
A questa sorta di impasse, Gino Giometti – l’altro ospite di quella puntata del programma – offre una possibile via di fuga, dal momento che suggerisce di pensare la prosa di Barlocco come quella di «un Landolfi americano che ha letto Lovecraft», e quindi un’esperienza vicina ad un filone che va oltre la tradizione italiana, specialmente quella di quando il nostro era in vita.
FRA I RACCONTI di Un negro voleva Iole, quello che forse mostra in modo più pronunciato l’intreccio di due caratteristiche presenti un po’ ovunque, cioè grottesco e violenza, è La mani.
Qui, c’è un protagonista che si trova a scontrarsi con i propri arti, in un crescendo di situazioni i cui estremi, con i loro correlativi oggettivi (la gogna per le mani; i binari per la doppia esecuzione) indicano l’immobilità umana come una specie di tendenza esistenziale generale, da cui poi, come nelle altre storie, sembrano alla fine scaturire per lo più sangue o ghigni.
«Molti animali inferiori, specialmente i vermi, putrefacendosi emettono una piccola luce; gli uomini invece puzzano». Da buon anti-umanista, Barlocco non sembra scrivere per il prossimo suo. O meglio, non è compiacente, né gli interessa esserlo. E per questo, in fondo, non possiamo che leggerlo con ammirazione.