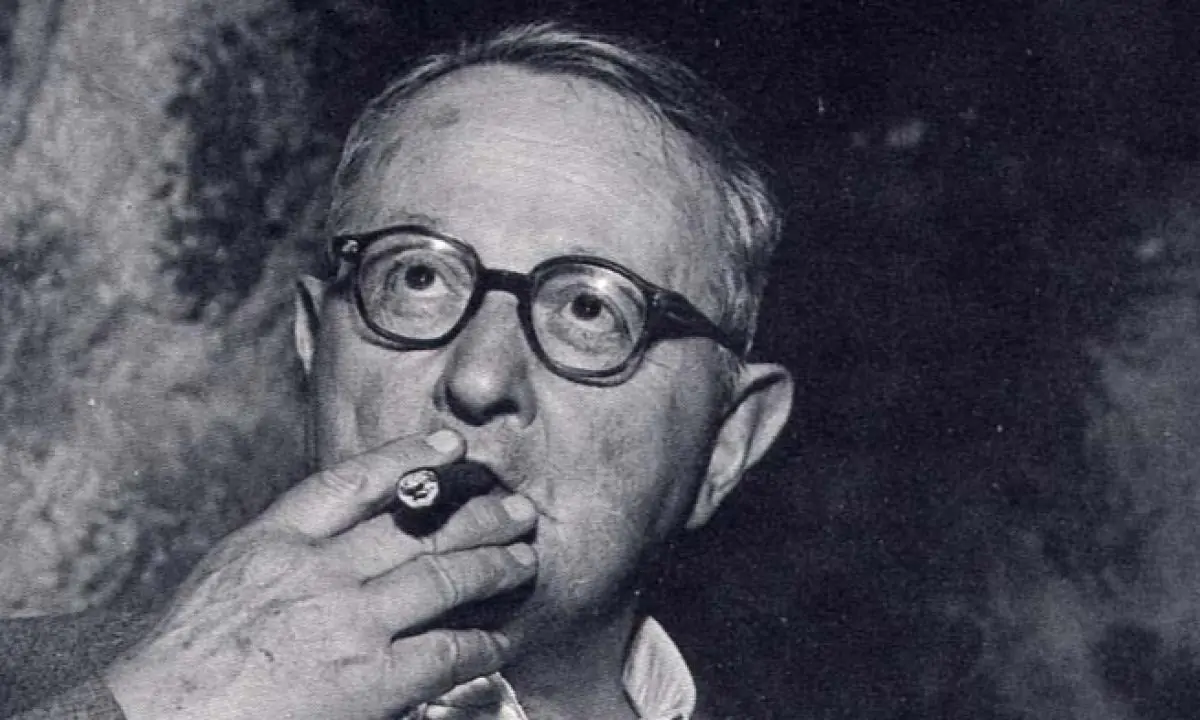Il mondo letterario di Camillo Sbarbaro, poeta ligure con una sconfinata passione per la botanica e per i licheni, pone le sue radici nel lirismo essenziale che imprigiona nei versi il disagio verso il fluire dell’esistenza. Sbarbaro, nonostante tragga ispirazione dalla poetica pascoliana, descrive le brutture esistenziali con placidità e pacatezza; il suo universo poetico, infatti, è una perpetua descrizione dei piccoli accadimenti della vita seppur mai con astio verso l’esistenza ma, anzi, con una modalità sommessa e, si potrebbe dire, quasi bisbigliata. Poeta legato visceralmente alla sua terra, descrisse con maestria i colori suggestivi della sua Liguria creando, nel lettore che si accinge alle sue raccolte, un fluire onomatopeico di suoni, colori e caratteristiche tipiche dei paesaggi liguri.
Camillo Sbarbaro è conosciuto, soprattutto, per la silloge poetica ‘’Pianissimo’’ edita per la prima volta da ‘’La Voce’’, nel 1914, a Firenze. Di questa raccolta si contano, però, tre edizioni; quella originale del 1914, la seconda edizione edita ‘’Pozza’’ a Venezia nel 1954 e, successivamente, un’ulteriore edizione dell’editore Scheiwiller di Milano nel 1961.
Il tema predominante della raccolta è, come consuetudine continuativa al mondo letterario del poeta, il disagio esistenziale; quel vuoto interiore creato dall’innata incapacità umana di creare un rapporto di sinergia e armonia fra soggetto e contesto reale, in cui l’essere umano milita durante la sua esistenza.
Gli influssi della poesia francese e di Baudelaire nella raccolta ‘’Pianissimo’’
La raccolta ‘’Pianissimo’’ custodisce, fra i versi che la compongono, numerosi riferimenti alla poesia simbolista francese e, soprattutto, a Baudelaire. La poetica di Camillo Sbarbaro è spesso stata definita ‘’leopardiana’’ ma dai toni crepuscolari, eppure alcune tematiche sono in linea con lo spleen descritto da Charles Baudelaire; l’espediente letterario che dona alla poesia di Sbarbaro una linea più intimistica, però, è dovuta alla volontà di creare un rapporto contraddittorio fra le tematiche scabrose e i temi familiari. Il poeta ligure utilizza la città come se fosse un riflesso: un grande palcoscenico in cui si rispecchia la sua abulia, un’apatia che diventa un mezzo di cui Sbarbaro si serve per connettersi e identificarsi agli strati più umili e relegati della società: prostitute, ubriachi, uomini senza fissa dimora. Il poeta tenta di ricreare un percorso interiore autentico attraverso queste tematiche che connette ai temi degli affetti familiari e, ancor prima, all’atmosfera perduta dell’infanzia:
«Andando per la strada così solo / tra la gente che m’urta e non mi vede / mi pare d’esser da me stesso assente.»
Sbarbaro: il mondo come un deserto e l’inadattabilità dell’Io alla società
Spesso relegato ai margini della letteratura, confinato per dar spazio alla grande poesia, si è andato a cristallizzare il pensiero per cui Camillo Sbarbaro fosse un autore di facile comprensione, quasi provinciale o banale. Tuttavia, proprio nella raccolta ‘’Pianissimo’’, il poeta fa luce su una realtà che coinvolge le società di ogni tempo: l’inadattabilità del soggetto al proprio contesto.
«… e il mondo è un grande / deserto. / Nel deserto / io guardo con asciutti occhi me stesso».
L’autore frammenta sia la figura del poeta che quella stessa di soggetto vivente in un dato contesto: il mondo è inteso come scisso attraverso forme antitetiche che, paradossalmente, convergono nella silloge in una dimensione strutturale coerente e lineare. Ma la genesi emozionale da cui prende vita la raccolta ‘’Pianissimo’’ è la morte del padre di Sbarbaro:
«Padre, se anche tu non fossi il mio / padre, se anche fossi a me un estraneo / per te stesso egualmente t’amerei.»
Un sentimento luttuoso che tornerà anche nella silloge Trucioli (1920), seppur in altre forme, connesso agli eventi della Prima Guerra Mondiale e allo sgretolamento che la tragedia bellica aveva arrecato al paese. Proprio nella consapevolezza della fugacità degli attimi e dell’effimera sostanza delle cose, Sbarbaro si aggrappa all’elemento naturale che diviene necessario, così come è impellente l’utilizzo di un appellativo da donare al fenomeno naturale, riflessione della piena potenza evocatrice della parola poetica:
Capisco, adesso, perché questa passione
ha attecchito in me così durevolmente:
rispondeva a ciò che ho di più vivo,
il senso della provvisorietà.
Sicché, per buona parte della vita, avrei raccolto,
dato nome, amorosamente messo in serbo….
neppure delle nuvole o delle bolle di sapone
– che per un poeta sarebbe già bello;
ma qualcosa di più inconsistente ancora:
delle effervescenze, appunto.
“Licheni”
In un certo senso, Camillo Sbarbaro cerca di esorcizzare quel senso di provvisorietà di cui parla nella poesia ‘’Licheni’’, ma che pure permea la sua intera produzione poetica, attraverso la siglatura: il dare un nome alle cose diventa esercizio di placidità per arginare le piccolezze fugaci di cui la vita di ogni uomo è puntellata. In sostanza, Sbarbaro tenta di appagare la sua provvisorietà verso la vita con la tangibilità di ciò che è visibile, dando un nome alle cose che lo circondano.
Quella di Sbarbaro si potrebbe definire una ‘’poesia del risveglio’’. La sua missione consiste nel tentare di scuotere l’uomo ingarbugliato e sopraffatto dalla civiltà moderna, con cui diviene quasi impossibile la comunicazione. “Pianissimo” è una raccolta che descrive la condizione del poeta, la sua sofferenza, ma che ben si presta nel descrivere le circostanze esistenziali di ogni uomo.
Lo stato di sofferenza individuale diventa voce ‘’sommessamente urlata’’ che pare far affermare al poeta ligure che il dolore sì, è parte integrante del mondo, che esiste un’incomunicabilità di fondo fra l’Io e la realtà circostante ma che un baluginio di speranza, forse, può scorgersi: non afferma questa possibilità, ma nemmeno la nega. Sbarbaro, attraverso la silloge ‘’Pianissimo’’ sembra quasi dire al suo lettore che, magari, è possibile esorcizzare la sofferenza in modo individuale, attraverso appigli soggettivi.