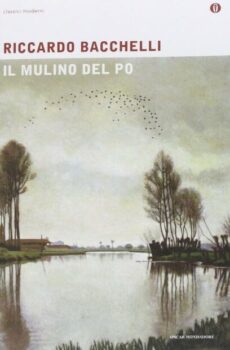Silvio D’Arzo in “Casa d’altri” (1952, “Botteghe Oscure“, Quaderno X, Roma), fonde armoniosamente il minimalismo esistenziale (ovvero la noia, la povertà di stimoli, di relazioni sociali) e il minimalismo narrativo. Secondo molti critici di oggi e secondo molti esponenti della Neoavanguardia si può scrivere anche di niente, senza una trama avvincente, addirittura senza una trama.
È proprio questo un modo per mettere alla prova e vedere chi è un autentico narratore e chi no. D’Arzo ha superato brillantemente questo esame. Il racconto, definito perfetto da Montale ed il più bel racconto italiano del Novecento da diversi critici letterari, si può riassumere tutto con queste parole: “Un’assurda vecchia: un assurdo prete: tutta un’assurda storia da un soldo”.
Trama e contenuti di Casa d’altri
È un racconto di poche decine di pagine, scritto con grazia, leggerezza e maestria, che si legge tutto di un fiato. D’Arzo non ha avuto il tempo, essendo morto di leucemia a soli 32 anni, di scrivere il romanzo della sua generazione come voleva e neppure di veder pubblicata da una importante casa editrice i suoi racconti.
Lo scrittore ha creato il suo capolavoro “Casa d’altri” sul finire della sua vita, nei suoi ultimi mesi. D’Arzo era troppo versato nella letteratura inglese e scriveva in modo lineare, mentre la vita è complessa e contraddittoria: questo potranno obiettare coloro che hanno dimenticato il grande narratore emiliano e lo hanno relegato ai margini della letteratura italiana del Novecento.
D’Arzo arriva al conquibus, arriva subito al dunque, non complica ulteriormente le cose già complicate di per sé, arriva come si suol dire al nervo delle cose, non si perde in preamboli, digressioni, astrazioni: questo possono affermare con buona ragione i suoi estimatori, infischiandosene dei canoni e della fortuna critica.
La realtà secondo D’Arzo
Pavese, direttore dell’Einaudi, rifiutò di pubblicare “Casa d’altri”, ma forse più che per motivi letterari e stilistici per ragioni prettamente esistenziali, perché il tema del suicidio era un suo nervo scoperto, qualcosa che gli procurava angoscia, un vero fantasma della sua mente fin da tempi immemorabili ed insospettabili, come si può desumere leggendo il suo diario.
Uno scrittore può prediligere la materia inanimata, gli altri o sé stesso. Ci sono incognite e incertezze per ognuna delle tre vie. L’importante è che, indipendentemente dalla sua scelta, si tratti di predilezioni e non di ossessioni, altrimenti uno diventa monotematico. Ma non ci sono solo queste tre dimensioni del reale.
Ci sono anche lo spazio, il tempo, gli accadimenti del mondo. Tutte queste dimensioni interagiscono tra di loro. Tutto dipende dall’osservatore, dal sistema di riferimento come in fisica, ma anche dal termine di paragone. La scrittura infatti è sempre paragone, accostamento, nel caso più semplice similitudine. D’Arzo è esemplare nel trattare tutti i piani della realtà e ad intrecciarli in modo poetico ed enigmatico.
La noia
C’è chi ha a noia la vita perché ha vissuto troppo o troppo poco in Casa d’altri. Una vita noiosa è altamente stereotipata, ripetitiva, alienante. C’è la depressione endogena. C’è la depressione reattiva, causata da traumi ed eventi spiacevoli. Nel caso specifico alla donna protagonista del racconto mancano le occasioni, gli eventi, una vita accettabile.
Ma c’è anche la noia che assale, la monotonia che non riesce a scalfire. Sembra una montagna insormontabile per Zelinda, vedova e lavandaia. Lo spleen di Baudelaire, l’assurdo di Camus, l’anello che non tiene e il male di vivere di Montale: i riferimenti gnoseologici e culturali possono essere molti per D’Arzo.
In Casa d’altri, il peso di vivere per Zelinda si fa intollerabile. La vita si presenta a lei sempre nello stesso modo: la trafila di giorni sempre uguali, le stesse cose da fare, la solita routine. Ma è anche una vita di stenti, una vita fatta di fatica, “una vita da capra”.
Scrive D’Arzo: “Con due si cerca meglio la verità”. Nietzsche scriveva che uno solo ha sempre torto, ma con due inizia la verità. Di certo gli interrogativi incessanti di Zelinda sono un fardello troppo ingombrante e troppo peso per portarli da sola.
Non trova più ragion di essere. È disperata perché ha perso speranza. Ma nel racconto D’Arzo si sofferma più sugli interrogativi angoscianti, sul suo rovello interiore causato da essi, che sul vuoto esistenziale della donna.
La fede e il dubbio
La domanda cruciale è se può finire prima la sua vita. Il prete non trova parole. Abbiamo due protagonisti: una vedova stanca di vivere, un prete di campagna e sullo sfondo Montelice, un paese in cui non accade mai niente (“sette case addossate..due strade, un cortile che chiamano piazza, uno stagno e un canale e montagna quanta ne vuoi. Che fanno qui a Montelice? vivono e basta e poi muoiono..qui non succede niente di niente…gli uomini al pascolo..le donne a far legna..in strada una vecchia o una capra o nemmeno quello..l’inverno dura mezzo anno. due mesi continui di pioggia, due tre mesi di neve-neve. non succede niente di niente solo che nevica e piove e la gente nelle stalle a guardare la pioggia e la neve come i muli e le capre..”).
Da una parte Zelinda, ovvero la credente con il suo dubbio incessante, e dall’altra il prete, con la sua dottrina, ma anche le sue perplessità. È un dialogo tra due fedeli, tra due fedi. Da un lato l’interrogativo della donna, dall’altro il prete, per cui diventa una ossessione, un cruccio, un enigma la vita di Zelinda. Entrambi sono attraversati da esitazioni.
Ci si può uccidere? È questa la domanda di Zelinda al prete. Ma è questa la risposta che deve dare la letteratura. Vale la pena vivere? I suicidi sono degli impazienti scriveva Bufalino. Vale la pena pazientare? Secondo la religione cristiana il suicidio è un atto di natura violenta contro sé stessi, è l’omicidio di sé stessi.
Il cupio dissolvi
Tutte le religioni condannano il suicidio. Secondo la moderna psichiatria la stragrande maggioranza dei suicidi sono depressi e la depressione può essere curata con gli psicofarmaci e la psicoterapia. Ma ai tempi di Silvio D’Arzo queste cose non si sapevano. Di solito si cerca sempre di rimandare.
Si cerca addirittura di procrastinare l’improcrastinabile. Bisogna non pensare alla morte per vivere pienamente. Bisogna pregare per salvarsi. Ma perché pensare egoisticamente alla propria salvezza individuale? Come scrive Camus a cosa serve la mia salvezza se non si salva l’umanità? Se ognuno ha le sue certamente le sue colpe, ma anche le sue giustificazioni, i suoi alibi e la possibilità di espiare allora forse sarebbe meglio sperare in un Dio talmente misericordioso da lasciare l’inferno vuoto come teorizzato da taluni teologi.
La chiesa condanna sia l’atto che l’attore. Esiste il libero arbitrio. C’è sempre un frangente per chiedere aiuto agli altri. Bisogna sempre trovare la forza per non sopprimersi, per vincere il cupio dissolvi, per far vincere l’istinto di autoconservazione. Il suicidio è talvolta questione di un istante. Il suicida per alcuni resta prigioniero di un istante, in cui azzera ogni possibilità, ogni speranza. In questo racconto il suicidio sembra invece il frutto di una scelta maturata da tempo e ben ponderata.
La Chiesa ammette eccezioni? Zelinda considera il suo un caso particolare. Non ha più vitalità. Non ha più voglia di vivere. Ed allora chiede se se ne può andare anzitempo in punta di piedi. Ritiene di aver già mangiato il suo pane, di sapere come sia la vita.
Ritiene che non ci sia più niente da conoscere e da vivere. Ha fatto il suo bilancio esistenziale. Ha tirato le sue somme. Dalle cose che le sono capitate, dalle persone che ha incontrato, dalla vita che ha fatto, dalla porzione di mondo e di realtà che ha vissuto, ha tratto le sue conclusioni: non vale più la pena vivere.
È una considerazione personale che per lei diventa certezza assoluta. La sorte ormai per lei non ha più niente in serbo. Non ci sarà più nessuna sorpresa. La vita per lei sarà sempre la stessa e lei non ne può più. Zelinda si è scordata che anche la vita più arida, più grama può essere riscattata, può essere un dono. Ma lei si considera una donna di 63 anni che è ormai senza futuro. Che cosa possono fare le parole di fronte a questo dramma?
Case d’altri: una macro-metafora della vita e della morte
Che cosa può fare la religione incarnata qui da un prete? Ma qui il dramma è doppio. Anche il prete ormai è un sacerdote da sagre di paese. È prossimo alla pensione, al congedo, all’addio, alla morte. Tutto questo si svolge in un piccolo paese, in un piccolo mondo angusto. D’Arzo narra l’inenarrabile, due vite avvolte dall’insensatezza, dall’assurdità di esistere. Il linguaggio è povero di figure retoriche, ma l’intera vicenda è una macro-metafora della vita e della morte, che si intrecciano in modo indissolubile.
D’Arzo è implacabile. Crea un congegno perfetto. Scrive in modo essenziale l’essenziale della vita e della morte. Toglie nello stile e nella trama ogni orpello, ogni ridondanza.
Leva tutto il superfluo. Rimane per queste poche pagine il mistero che ci irretisce e ci incupisce, la sospensione. Le vite degli uomini sono tutte diverse. La sofferenza, le vicissitudini, la stanchezza di esistere non sono uguali per tutti. Alcuni vengono messi più alla prova dalla vita di altri. Secondo la teologia cristiana il suo disegno è imperscrutabile, sfugge alla logica umana, ma Dio valuta ogni caso in modo equanime, soppesando tutto, qualsiasi cosa.
“Ognuno ha una ragione valida per uccidersi”, scriveva Pavese. Ma si uccidono solo coloro la cui sofferenza interiore per stati d’animo o eventi nefasti ha sorpassato ogni livello di sopportazione. Se si mette sul piatto della bilancia ci sono svariate ragioni per uccidersi e svariate ragioni per continuare a vivere.
Viene considerato razionale continuare a vivere. Ma è pura convenzione. Allo stesso modo viene considerato più coraggioso continuare a vivere che farla finita. Si ritiene a torto o a ragione che quando una persona si uccida o tenti di uccidersi perda il senno della ragione. D’altronde la cultura e la società devono essere biofile. Non si può fare altrimenti.
Condannare il gesto estremo è un modo per dissuadere gli indecisi o coloro che si trovano in difficoltà. È un modo per interrompere l’emulazione dell’estremo gesto. Condannare il suicidio è un modo per mandare avanti il mondo, pur ammettendo la pietà cristiana per la vittima. Alla domanda di Zelinda c’è la risposta secca del prete: non sono ammesse eccezioni.
Il prete risponde che per la morte propria ed altrui non si decide noi, ma decide Dio. Nessuno può anticipare i tempi. Nessuno deve disperare. Zelinda però viene trovata morta. Nessuno sa se l’ha fatta finita. Forse lo scrittore emiliano lascia alla fine alla donna la libertà di autodeterminarsi. Il prete è prossimo a lasciare il paese per tornare a casa.
Una situazione senza via d’uscita
Ad ogni modo il prete, che rappresenta la religione, esce sconfitto. Sicuramente la pecorella smarrita non è tornata nell’ovile. Ma probabilmente dall’ovile, dalla ortodossia religiosa si era allontanata solo con i pensieri, con i tarli della sua mente. Sorge spontanea una domanda, leggendo D’Arzo: è giusto che Dio condanni Zelinda, che ha vissuto una vita irreprensibile per una sola cattiva azione e che ha fatto del male solo a sé stessa?
Dio non potrebbe fare una eccezione ai suoi regolamenti? La risposta di qualsiasi prete probabilmente è che bisogna vivere cristianamente fino alla fine, fino in fondo.
Il racconto di D’Arzo tratta di una situazione senza uscita, ma nessuno sa se nella vita alla fine c’è una via di uscita oppure no. Grazie alla fede si può credere all’aldilà e alla salvezza, ma la logica umana, i fatti e la scienza lasciano in sospeso la questione proprio come D’Arzo. La vecchia è morta, le cose vanno come al solito, sta “per venire la morta stagione, gli sterpi secchi, le passere uccise dal freddo, la notte che arriva alle sei, i fossi ghiacciati, i vecchi che se ne muoiono in fila…”.
Talvolta la vita sembra un contorno sfumato, una domanda mal posta, una occasione mancata. Eppure sono tante le sfaccettature della vita. Siamo così presi ed immersi dalla quotidianità che ci dimentichiamo che è un dono: forse è questo il vero messaggio dello scrittore.
Di Davide Morelli