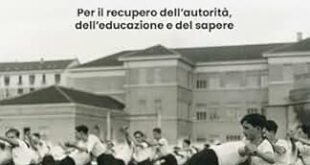Bruno Galluccio è uno straordinario autore che coniuga scienza e poesia nella sua opera: una poesia (molto ben recensita) attenta all’essenzialità, che si fa passaggio tra temi quali l’enigma dell’universo, il mistero, intrisa di un pieno umanismo in cui l’individuo è origine del sistema di riferimento. Sono continui i rimandi alla scienza, con diversi registri non proprio linguistici, direi piuttosto epistemici: il lessico si mantiene infatti sempre ricercato (cosa non scontata nella poesia contemporanea), pur senza barocchismi di maniera (cosa non scontata nella poesia in genere). Una voce non forzata, non ingombrante, non banale, ma affilata, di indubbio spessore artistico, quella di Bruno Galluccio: […]e io veglio anche/ per il tuo lembo di indicibile/ mentre la luce massacra l’ombra/ sul lato rovescio del pensiero.
Diversi registri epistemici, dicevamo: la poesia non è solo un resoconto della conoscenza, ma diventa veicolo di conoscenza. Non è solo senso verbale, ma anche senso percettivo e cognitivo. Questo aspetto, probabilmente collaterale alla sua formazione scientifica, questa contaminazione continua tra mondi troppo spesso, e a torto, ritenuti incomunicabili (l’arte, la scienza), è un esperimento molto interessante, e di certo ben riuscito. Protagonista di molti eventi (l’ultimo al MAN di Napoli, con letture accompagnate dalle musiche che Antonio Raja ha composto ispirandosi alle poesie di Galluccio; il prossimo nell’ambito della manifestazione “Futuro Remoto 2016”) e curatore di una sua rassegna napoletana (“La poesia al tempo del vino e delle rose”), Galluccio prende la poesia molto seriamente.
1.Partirei complimentandomi con te per il tuo recente lavoro “La misura dello zero”, non primo, ma secondo libro di poesie con un editore importante quale Einaudi: un risultato eccezionale, visto il mercato difficile della poesia.
(Ringrazia e sorride, poi si fa pensoso). Un mercato difficile, si, per motivi diversi: la poesia è impegnativa, il lettore non può leggerla passivamente. La poesia è difficile, e meno male: citando Jorie Graham, la poesia difficile è un regalo dell’autore al lettore. Di certo, la poesia non serve a niente, e tale è la sua forza: non si piega al compromesso delle cose utili. Ma per questo, non è immediato capirne la bellezza; secondo punto: la poesia entra poco nelle librerie, complice gli alti costi della distribuzione: eccezion fatta per piccole case editrici, si investe poco sui poeti. Quindi la poesia si compra poco. Quindi si legge poco. E dunque vi si investe poco. E così via, il cane si morde la coda; infine, è poca l’attenzione che i media dedicano alla poesia. Le recensioni di opere di poeti contemporanei sono eventi rari. Questo fenomeno è fortunatamente bilanciato dalla diffusione (che però non ha filtro alcuno) di versi via internet tramite social network, siti vari e blog.
2.Credi che c’entri anche la condensazione del tempo attuale, il ritmo così sostenuto di un presente privo di raccoglimento, di un caos dettato dalla frenesia quotidiana?
Credo che ci si debba abituare alla lettura. Io, per esempio, riesco a leggere poesie praticamente ovunque, ormai. In questo credo rientri anche il gusto personale, come nell’uso dei libri elettronici. Tu per esempio, li leggi?
Io sono un maniaco della carta stampata. Odore, fruscio, avorio. No, non li leggo.
Ti capisco, ma è innegabile che la rete permetta una distribuzione incredibilmente efficace della letteratura: si possono comprare testi, anche cartacei, dopo magari averne letto qualche estratto interessante; si possono conoscere autori stranieri, altrimenti inaccessibili, tradotti certamente in inglese, o addirittura in italiano.
3.Le traduzioni: quanta giustizia rendono alla poesia?
La traduzione è un male inevitabile, come dice Nicola Crocetti. Meglio leggere poesia tradotta che non leggerne affatto. L’ideale sarebbe, certo, avere un testo in lingua madre a fronte. La traduttologia presenta dilemmi insolubili: in caso di dubbio, meglio privilegiare il senso o il ritmo? Meglio essere traduttori non poeti, per evitare contaminazioni altrimenti inevitabili? Per non parlare dell’insidia dei termini “falsi amici” tra una lingua e l’altra… Più le lingue sono tra loro lontane, poi, più il discorso si complica.
4.A me, per esempio, piace la poesia russa. La Achmatova, o Mandel’štam, per esempio. Ma ho il timore di non averli mai letti davvero.
Condivido in pieno la tua passione. Dicono che la poesia russa tradotta sia solo un pallido riflesso di quella originale. Certa è la capacità dei russi di leggere e recitare la poesia. Sai, in Russia la poesia è molto amata, ha molto pubblico. In Germania, lo stesso.
5.Molti credono che la poesia sia pura ispirazione. Quanto lavoro c’è dietro?
Io non intendo la poesia, prendendo un’orribile espressione usata talvolta, come “vomito dell’anima”. La poesia richiede lavoro. C’è un’idea iniziale che si va affinando. Di getto su può buttar giù, nero su bianco, soltanto uno scheletro del risultato finale.
6.Un atto volitivo e ponderato, certo. Altrimenti, dove si collocherebbe, in questo paradigma, il talento?
Appunto. Personalmente ripasso spesso sulle mie poesie.
7.Come sai che le stai migliorando, e non snaturando?
È un problema che mi pongo di continuo. È un rischio che il poeta deve assumersi. Le poesie lunghe possono diventare brevi, le brevi lunghe, perché magari ti rendi conto di aver detto troppo, o troppo poco, o male. Anche questo è fare poesia.
8.Che importanza ha il ritmo nella tua poesia?
Io scrivo versi liberi, mi piace calarmi in una metrica, e spezzarla con un elemento di disturbo. Il ritmo va organizzato con consapevolezza, ma senza rigidità schematiche. Alcune poesie, per esempio, possono essere musicali a tal punto da risultare fuori luogo rispetto al proprio contenuto.
9.Che rapporto hai con i miti? A quali poeti ti senti più legato?
Il senso di identificazione con gli autori del passato è a volte inevitabile. Questo accade soprattutto quando si è molto giovani, col tempo si trova una voce propria. Per fare qualche nome: credo che Leopardi sia insuperabile; amo Celan, Rilke, Eliot; Anne Sexton, una poetessa dalla voce forte, ed una delle donne più belle che io abbia mai visto; Emily Dickinson, di cui ho tradotto qualche poesia; poeti che non possono non piacere, come Baudelaire e Kavafis; Wallace Stevens, che è stato per un certo tempo mio riferimento; non mi sento in sintonia con la poesia di Ezra Pound e Sandro Penna, pur riconoscendone il valore; apprezzo molto Bonnefoy e Mario Luzi.
10.La bellezza in poesia ha a che fare con l’eleganza in matematica, intesa come rinuncia al superfluo?
Ne sono convinto. Entrambe si rifanno alla simmetria, all’essenzialità. Pensa alla formula di Eulero, che mette in relazione entità fondamentali della matematica, il numero di Nepero, l’uno, lo zero, la costante pi greco.
La formula di Eulero sembra un quadro dipinto.
Esattamente.
11.Cosa accomuna il numero e la parola? Credi che, così come il mistico Numero pitagorico, anche il Verbo abbia una funzione creatrice, intendo dire in senso quasi biblico?
Domanda impegnativa. Credo dipenda dal livello che si considera. Ad un livello più basso, entrambi servono a comunicare le cose: un significato, una quantità. A livello più profondo, simbolico, le creano. Vedi, io evito le definizioni troppo altisonanti della poesia. Per me la poesia è semplicemente l’uso più alto che si può fare della parola.
Del resto il linguaggio scientifico è spesso evocativo quanto quello poetico.
Certo. Pensa alla “sezione aurea”, per dirne una. Scienza e poesia si completano. Un teorema non può essere bello senza una riflessione ulteriore. E la poesia, d’altro canto, giunge a conclusioni del tutto arbitrarie senza la prima. E poi la poesia è un’attività umana, e in quanto tale non può disinteressarsi alla scienza. La poesia valorizza la scoperta, con stupore e rispetto. Del resto, Feynman si chiedeva perché, se è poetico un fiore, non dovrebbe esserlo anche la sua struttura interna microscopica, seppure in modo diverso. Aggiungo poi che, la matematica, non può solo essere oggetto di poesia, ma anche un ausilio ad essa, come fonte di metafore.
12.Ma la poesia, va capita?
Può essere capita a strati. Può essere fruita a livelli più o meno profondi. Il poeta ha spesso l’impressione, quando scrive, che non potrebbe dire la stessa cosa usando un linguaggio diverso. Che non potrebbe esprimersi in modo più semplice. Io per esempio ho bisogno, a volte, di utilizzare anomalie sintattiche. Di cambiare improvvisamente soggetto. È una necessità talvolta, più che una scelta. La poesia è così difficile per chi la legge, ma così remunerativa, proprio perché è stratificata. Bisogna prestare attenzione al linguaggio, e trovare la propria voce. Una definizione di poesia è inafferrabile come una definizione dell’amore: a quanto pare tutti ne hanno un’idea più o meno simile, ma non per questo è meno incomunicabile.
[…] la pioggia si ferma e cerca l’acqua
c’è un momento di materia nel flusso straniante
metà pozzo metà galleggiamento
e cominciamo a riacquisire i nuclei e lo spazio
la sfera che ci nutre e contiene.
 '900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera
'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera