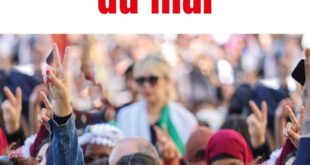Carlo Tortarolo ama stupire e provocare, pungolando il politicamente corretto che sempre più spesso corrode la nostra società. Lo fa pungolando il lettore con l’opera “Lo scultore di uragani”, Coniglio editore, 2025, con uno stile incisivo e metaforico, che non lascia troppo scampo a scappatoie intellettive.
Lo scultore di uragani è una storia scritta di volta in volta dall’autore insieme al lettore invitato a collaborare alla riflessione di Tortarolo, poliedrica e divertente costruita su saggi pungenti, aforismi alla Leo Longanesi e racconti-parabole evocativi, offrendo ai lettori una chiave di lettura originale per interpretare le sfide della società contemporanea e le sue storture, soprattutto ideologiche.
Frutto di recupero di racconti precedenti, cui si sono aggiunti altri, Lo scultore di uragani, vive di ironia amara, di giochi di parole, di intuizioni illuminanti che descrivono la tristezza della nostra civiltà, dell’Occidente che, come ormai si sente dire da decenni, è come un treno nella notte la cui corsa va sempre più accelerando in direzione del baratro mentre «L’uomo occidentale è come il passeggero del Titanic che […] (aveva) l’illusione di essere a bordo di una nave inaffondabile». Ma è possibile pensare ad un futuro diverso senza dover ripetere sempre che l’Occidente è morto o sta morendo, esibendosi solo come cantori dello sfacelo dell’Occidente?
Per Tortarolo la strada risiede proprio nel senso di possibilità insito dell’animo umano, nel riscoprire la nostra linfa vitale che ci permette istintivamente di comunicare vita, passione, visione del futura, anche attraverso la letteratura, contro la cultura mortifera post strutturalista.
1 Perché hai deciso di scrivere questo libro?
Non l’ho deciso. Mi è stato chiesto. L’editore mi ha domandato se avessi qualcosa di pronto e io ho risposto col disordine delle mie prime scritture. Ho recuperato i racconti usciti su Satisfiction, li ho riscritti, ne ho aggiunti altri, e li ho lasciati esplodere insieme.
2 Qual è la principale crisi che stiamo vivendo, la madre di tutte le altre, secondo te?
La crisi della felicità.
Abbiamo trasformato ogni desiderio in un diritto, e ci siamo trovati infelici lo stesso.
Viviamo in una civiltà triste, che ha perso il gusto per le piccole cose, per la serata senza smartphone, per il silenzio non monetizzato.
Siamo in lutto per la morte del presente.
3 È stato complicato pubblicare questo libro?
No. Ho avuto la fortuna rara che Coniglio Editore mi abbia cercato.
La vera difficoltà è stata scegliere cosa pubblicare. I racconti erano la forma giusta: tagliano, scivolano, si possono leggere come mine o come specchi.
4 Ad un certo punto fai dire ad un personaggio: “Vede Gilberti, gli italiani non sono ancora a pronti ad accettare la verità”. Quale verità per gli italiani è la più difficile da mandare giù?
La più indigesta è questa: non siamo mai stati davvero liberi, e non ce ne frega nulla.
L’Italia è un algoritmo emotivo: riesce a coniugare l’essere col non essere, il furto con la retorica, il disincanto con l’autoassoluzione.
La nostra verità è un compromesso che ci consente di sopravvivere senza fare i conti con noi stessi.
5 Quali sono i tuoi punti di riferimento letterari? Tre nomi
Dante, Céline e Longanesi.
Dante per la bellezza che non chiede permesso.
Céline per la dissezione dell’uomo e il furore stilistico.
Longanesi perché sapeva fuggire da ogni forma di banalità come fosse peste.
6 Cosa pensavi o speravi mentre scrivevi “Lo scultore d’uragani”?
Pensavo di fare male. Ogni racconto è un colpo: secco, chirurgico, fastidioso.
Scrivo per disturbare la stasi, per svegliare da quella pseudovita narcotizzata che non ha più bisogno dell’intelligenza umana.
Questo libro è un atto di resistenza contro l’idea di un uomo ridotto a entità gestibile da un’élite di debosciati.
Il libro li disegna. Li espone. Li brucia.
 '900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera
'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera