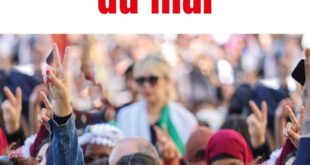Sguardi nell’abisso. Apocalissi, gender e virtualità nell’età del nichilismo, di Simone Perron, edito da Passaggio al bosco, fa parte di una ragguardevole compagine culturale antimoderna che non si rassegna alla deriva “nichilista” che ormai caratterizza la nostra società tecnocratica. Come recita la prefazione, il libro di Perron non dice assolutamente nulla di originale, se non per qualche sfumatura personale su di uno sfondo genericamente tradizionalista, soffre probabilmente della stessa malattia che diagnostica nella società. Ovvero un certo egoriferimento, che distorce il mondo dietro ad una personale lente scura, e quindi, lo dipinge a tinte pessimistiche.
Viviamo in un’epoca di transizione tumultuosa, un’età del nichilismo in cui i vecchi ancoraggi si sgretolano e nuove narrazioni faticano a emergere. In questo saggio dissidente e controcorrente, Simone Perron intraprende una lucida e impietosa analisi delle derive contemporanee, offrendo uno sguardo senza filtri sull’abisso che la nostra società sta contemplando.
Partendo da una visione critica del trionfo dell’indifferenziato e della mercificazione dell’esistenza, l’autore esplora le implicazioni radicali delle ideologie di genere, le insidie del mondo virtuale e il senso di un’imminente apocalisse culturale e sociale. Attraverso una disamina coraggiosa e non convenzionale di temi spesso taciuti o affrontati con superficialità – dalle ambigue frontiere dell’eros alle allucinazioni indotte dalla tecnologia, fino alla crisi di senso e alla perdita di riferimenti stabili –, “Sguardi nell’abisso” si rivolge al “Ribelle” che nuota controcorrente, a chi non teme di interrogare le certezze del nostro tempo e cerca prospettive inattuali e di rottura.
Se è vero che il primo antidoto al nichilismo è la consapevolezza del mondo in cui viviamo, è altrettanto palese che ormai il nichilismo nella volgarizzazione che ha preso piede, è diventato un atteggiamento pessimistico e distruttivo, ma perlopiù manchevole di una sua parte costruens e questo aspetto purtroppo riguarda spesso anche i cantori della fine dell’Occidente.
Il testo di Perron dimostra invece come il vero nichilista anche se non crede in nulla, non è un uomo privo di speranza: egli è il distruttore, perché sa che solo abbattendo ciò che è vecchio si può costruire qualcosa di nuovo. E il vecchio oggi è il nostro presente.
1 Cosa significa essere controcorrente oggi? E quali sono i rischi?
Penso che essere controcorrente oggi significhi in qualche modo opporsi allo spirito del tempo, ovvero staccarsi da una visione del mondo totalmente legata allo scientismo (cioè la scienza diventata religione e dogma), all’idolatria della tecnica, all’egualitarismo radicale e ad una visione mercantile dell’esistenza, per la quale ogni cosa si può vendere o comprare. Già solo mettere in discussione questi dogmi imperanti sarebbe molto.
Il rischio è quello di sentirsi isolati, esuli in un mondo nel quale non ci si riconosce. È una sensazione che pervade molte persone, che tendono a riunirsi e a fare massa critica, anche grazie all’uso dei social media. È bene che sia così, ma vi è un rischio ulteriore: finire in un guazzabuglio di pensiero in cui tutto si equivale, in cui si rafforzano i bias, in cui tutto diventa irrazionale e confuso. Vi è un terribile conformismo e appiattimento anche nel cosiddetto “antisistema”, forse ancora più pericoloso perché in questo contesto ci si sente nel giusto in quanto lontano dal “mainstream”. Eppure essere lontani da un errore non significa per forza essere vicini alla verità.
2 Il nichilismo potrebbe rappresentare un’occasione di svolta intellettiva, identitaria e culturale per la nostra società?
Ci sono certamente forze latenti positive che diventano coscienti solo nei momenti più bui. Bisogna però vedere se saranno in grado di attivarsi. Per paradosso, abbiamo una società occidentale così progredita dal punto di vista materiale da garantirci le migliori condizioni di vita di sempre. Eppure ci manca qualcosa. Sentiamo che qualcosa non va. Siamo narcotizzati, indotti a distrarci con la televisione o internet, storditi dal troppo lavoro, dalle droghe e dagli alcolici. Finché abbiamo queste stampelle, restiamo in una sorta di limbo. La svolta è possibile, ma forse bisogna avere il coraggio di buttare via le stampelle una volta per tutte. Camminare da soli, o cadere con dignità. Sempre meglio che vivere da zombie.
3 Quali sono i suoi autori di riferimento?
Sono cresciuto con i libri di Carlos Castaneda, Noam Chomsky e J.R.R Tolkien. A trent’anni sono stato folgorato da Friedrich Nietzsche. A quaranta da Julius Evola e dai Tradizionalisti. Penso che questi ultimi esprimano una concezione del mondo totale e coerente, una capacità di analisi così onnicomprensiva riguardo ad ogni aspetto dell’umano – e del trascendente, da costituire un faro esistenziale importante in questi tempi di spaesamento collettivo.
4 Qual è l’ambito che risulta il più critico in Italia e che potrebbe fare da traino ad altri settori per un rinnovamento culturale?
Probabilmente la scuola. Forse perché insegno da anni nelle scuole medie e negli istituti professionali e tecnici, ma ho visto troppo spesso talenti e capacità sprecati o addirittura annichiliti. Finché continuiamo a pensare che “tutti possano – e debbano – fare tutto” costruiremo una società di persone frustrate e sempre fuori posto. Vi sono individui portati per i lavori manuali, veri e propri assi nel loro campo, costretti ad imparare malamente materie alle quali non sono minimamente interessati. Altri, portati alla speculazione intellettuale più raffinata, costretti a fare fotocopie nell’alternanza scuola lavoro. Il mito egualitario progressista ha fatto danni enormi. Andrebbe sradicato alla radice. Ma abbiamo trasformato anche l’insegnante in uno scialbo burocrate, dunque il cane si morde la coda.
5 “La volontà di potenza non è altro che l’estrema realizzazione del dominio dell’essere sull’essere stesso”, diceva Heidegger. Come vede questo pensiero in relazione alla nostra società?
La volontà di potenza è anche volontà cieca di autosuperamento. Fa parte dell’animo europeo, quello che forgerà l’uomo faustiano secondo Osvald Spengler. Ciò sta portando al superamento della modernità, ovvero alla post- modernità, figlia di questa continua sfida ai limiti che ci costringono dall’esterno. Ma siamo arrivati al punto da poter sradicare gli stessi fondamenti che ci rendono per definizione umani. La morte ad esempio: c’è chi sostiene che entro pochi anni potremo riportare indietro i processi di invecchiamento a nostro piacimento. Chiaramente cadendo da un palazzo si morirebbe comunque, quindi la prospettiva della vita fisica “eterna” ci renderebbe così pavidi da evitare qualsiasi attività pericolosa. Per paradosso, sceglieremmo di stare collegati ad un avatar virtuale per non rischiare la pelle. Che umanità sarebbe mai quella? Patetica.
6 Non sarebbe più corretto oggi parlare di fine del nichilismo a favore di un inutile pessimismo?
Con il passaggio dalla visione del mondo pagana a quella monoteista, abbiamo negato gli Dèi in favore di un unico Dio. Con la modernità abbiamo negato anche questo, in favore dell’individuo. Con i movimenti ambientalisti abbiamo provato a mettere la Natura al centro della nostra esistenza, come Dea madre: ma oggi anch’essa è percepita come debole e minacciata, tanto che con il riscaldamento climatico pensiamo che l’Apocalisse stia bussando alle porte. Lo stesso individuo, unico rimasto sul palcoscenico degli “enti”, è scisso in mille parti: una macchina desiderante e autoreferenziale, che può addirittura scegliere il suo “genere” e far finta che la biologia non esista.
Se saremo in grado di ritrovare un senso profondo dell’esistere, anche il pessimismo scomparirà come neve al sole. Finché questo non accadrà, temo che le visioni più pessimistiche siano ampiamente giustificate: affideremo alle intelligenze artificiali le nostre esistenze ormai svuotate di senso.
 '900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera
'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera