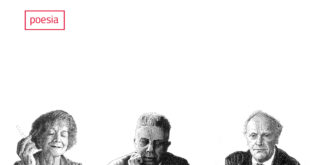Il nome di Pierluigi Cappello è stato per lungo tempo associato alla figura di un poeta delicato e schivo e, talvolta, non ricordato a dovere. Nato in Friuli nell’agosto del 1967, trascorre la sua infanzia a Chiusaforte; sono due gli avvenimenti sostanziali che segneranno per sempre la vita e la poetica di Pierluigi Cappello: il terremoto del 6 maggio 1976 e un tragico incidente all’età di 16 anni che lo confinerà su una sedia a rotelle fino alla fine della sua esistenza, il 1° Ottobre 2017.
Il poeta francese Paul Celan scriveva: “I poeti: gli ultimi custodi delle solitudini’’. E Cappello era un custode sì della solitudine, per via della sua innata riservatezza, ma anche della stessa arte poetica; in un’intervista tratta da «la Lettura» #147 ( Corriere della Sera) del 14 settembre 2014, alla domanda ‘’Pensa di aver scritto grazie alla malattia o nonostante la malattia?’’, risponderà:
«Nonostante quello che mi è successo, senza dubbio. Per scrivere bisogna poter mobilitare tutte le risorse, avere la disponibilità di un corpo che ti risponde. La scrittura passa per una unità biologica fatta di testa e corpo. Avere interne regioni che non comandi richiede uno sforzo enorme. Anche la capacità di concentrazione va conquistata. Non ci sono moventi precisi che ti portano alla scrittura: ci sono piccoli passi, sussulti dell’esistenza, c’è una passione che, secondo me, è innata. Ho cominciato con elenchi di parole, come un uomo di montagna che ha paura dell’acqua e inizia a metterci prima un piede, poi avanza un altro po’, fino a scoprire di starci bene».
Nel 1999 dirige insieme a Ivan Crico La barca di Babele, una collana di poesie edita dal Circolo Culturale di Meduno. Nel 2006 pubblica la quasi totalità delle raccolte dei suoi versi in Assetto di volo, a cura di Anna De Simone, edito Crocetti Editore: silloge che gli varrà prestigiosi premi come il Premio Nazionale Letterario Pisa, il Premio Bagutta 2007 sezione Opera Prima e il Superpremio San Pellegrino 2007. Nel 2010 pubblica ‘’Mandate a dire all’imperatore’’, con postfazione di Eraldo Affinati, edito Crocetti Editore; la raccolta valse a Cappello il Premio Viareggio. Sono chiari i riferimenti a Pasolini, quel legame con la civiltà contadina che sa parlare alle anime seppur tacitamente. Pierluigi Cappello è un poeta di montagna, un ricamatore di versi che germogliano delicati, direttamente, dalla “ποίησις” (poiesis). La poesia, in greco, deriva dal verbo poieō (“ποιέω”), fare o creare, e il poeta friuliano era un creatore di bellezza, di armonia della parola. Il suo è un italiano essenziale ma colto che si accosta alla poesia dialettale con eleganza e raffinatezza, riflesso dell’anima pura di Cappello. Il dialetto è una evocativa lingua che esprime significati ma, soprattutto, appartenenza e la destrezza e la capacità di padroneggiare due o più lingue, in questo senso, significa avere prospettive differenti sul mondo.
Allargare gli occhi alla ‘’cavezza del sogno’’: la poesia dialettale di Pierluigi Cappello
Inniò è un’antica parola friulana ma anche il titolo di uno dei più noti componimenti dialettali di Pierluigi Cappello:‘’In nessun dove’’. Una poetica onirica, quasi fiabesca, malinconica ma serena; versi che rimandano al bambino che è dentro di ognuno, a un’infanzia dimenticata che sempre si può riscoprire:
«Jo? Jo o voi discôlç viers inniò», «Io? Io vado scalzo verso inniò»
i siei vôi il celest, piturât di un bambin. i suoi occhi il celeste, pitturato da un bambino.
La dualità linguistica del poeta si riflette nella vita quotidiana ma, anche, nella sua poetica dove il friulano è utilizzato principalmente per esprimere e veicolare concetti intimi e legati alla propria tradizione mentre l’italiano è la lingua utilizzata per analizzare e parlare di tematiche universali.
In una costante danza armonica del lessico Pierluigi Cappello utilizza con rigore la lingua italiana dove in modo colto ed essenziale, da artigiano della parola, costruisce mondi incantati ma, tuttavia, realistici. D’altro canto l’utilizzo della forma dialettale da parte del poeta accompagna il lettore quasi come una nenia antica, progenie di una civiltà contadina oramai perduta. Negli usi della lingua Cappello sembra voler dire, sommessamente e indirettamente, che esistono concetti e versi che hanno quasi bisogno di essere espressi nella forma dialettale mentre, altri, nella lingua italiana. ‘’Il poeta è un vasaio’’, sosteneva Pierluigi Cappello; e proprio come un vasaio lavora l’argilla trasformandola in oggetti e forme utili, così chi ha l’ambizione di seguire la poesia e immergersi nel fiume Mnemosine, bevendo dalle sue acque ed entrando quindi in contatto con tale conoscenza ispirata, diviene artigiano della parola: una parola che è potenza, veicolo. La manipolazione del linguaggio che lima e trasforma la loquela e il pensiero, intersecando due materie grezze per creare arte e donare emozioni.
Piangere non è un sussulto di scapole
e adesso che ho pianto
non ho parole migliori di queste
per dire che ho pianto
le parole più belle
le parole più pure
non sono lo zampettio delle sillabe
sull’inverno frusciante dei fogli
stanno così come stanno
né fuoco né cenere
fra l’ultima parola detta
e la prima nuova da dire
è lì che abitiamo.
Assetto di volo (Crocetti, 2006)
La poesia dell’appartenenza e la poetica del sogno come visione oltre il dolore
La montagna friulana, il sussurro flebile delle foglie, gli ‘’orti poveri’’ e le ‘’ montagne azzurrine, di là dai muri oltre gli sguardi delle guardie confinarie’’ diventano memorie e simboli nello stile di Cappello; una poesia di appartenenza, di definizione, di fierezza che sottolinea il legame antico con il ricordo. Il rimembrare, il tempo e l’infanzia sono, infatti, fra i temi centrali nella poetica di Pierluigi Cappello. La montagna, il dialetto, il mondo semplice si configurano in piccole e quotidiane memorie che si tramutano in luoghi poetici eterni. L’intento principale è uno: recuperare la fragilità del passato per salvarla dall’oblio. In Ombre, tratta dalla raccolta ‘’Mandate a dire all’imperatore’’, il poeta friulano scrive:
Sono nato al di qua di questi fogli
lungo un fiume, porto nelle narici
il cuore di resina degli abeti, negli occhi il silenzio
di quando nevica, la memoria lunga
di chi ha poco da raccontare.
Il nord e l’est, le pietre rotte dall’inverno
l’ombra delle nuvole sul fondo della valle
sono i miei punti cardinali;
non conosco la prospettiva senza dimensione del mare
e non era l’Italia del settanta Chiusaforte
ma una bolla, minuti raddensati in secoli
nei gesti di uno stare fermi nel mondo
cose che avevano confini piccoli, gli orti poveri, le cataste […]
Cappello prima di essere un cantore di versi è un poeta montanaro, custode di rimembranze in quei luoghi dell’infanzia divenuti lirici, infiniti e imperituri. Ma oltre alla tematica dell’infanzia e dell’appartenenza, la poesia di Pierluigi Cappello si costruisce intorno alla forza della parola poetica come nastro incantato che tiene insieme la vita e la salva. La parola, nella visione del poeta, non è orpello asettico ma entità concreta che si tramuta in gesto di sopravvivenza. Lo stile letterario di Cappello si insinua in una poetica che non è mai vittimistica: nonostante il terribile incidente avuto a 16 anni e l’esperienza del terremoto, la sua poesia è sempre un tendere verso l’alto e una ricerca costante della libertà interiore; una libertà che è stata negata al corpo ma che può mettere radici nella mente, proprio attraverso la parola che si tramuta in verso. Un concetto similare a un altro grande poeta, Ovidio, che nell’opera Tristia (IV, X, 26) scrive, sottolineando la sua naturale inclinazione e la vocazione alla poesia:
‘’Quod temptabam dicere versus erat” “Ciò che tentavo di dire diventava verso”
Un altro dei temi centrali dello stile del poeta friulano implica l’affidarsi al sogno, l’essere quindi guidati dai sogni quando l’esistenza diventa zavorra; la visione onirica che propone Pierlugi Cappello, tuttavia, non ha risvolti illusori ma si concretizza in una dimensione spirituale: una leggerezza onirica, quasi come velo invisibile, che separa il reale dal fantastico. Per Cappello, infatti, il sogno non è una scappatoia: non è sinonimo di evasione o di alienazione dalla realtà ma, anzi, è fonte di luce che orienta e conduce, nella vita, a una prospettiva che va oltre il dolore. Quello che insegna attraverso la sua poetica è che nonostante la sofferenza la guida dell’uomo nelle sue difficoltà rimane sempre l’incanto; il suo è uno stile letterario essenziale e mai barocco e arzigogolato, capace di evocare immagini potenti e profonde dove le parole usate rifulgono di autenticità.
La memoria personale e il legame con la sua terra e il quotidiano permeano tutta la sua opera così come la dicotomia corpo/limite. L’incidente avuto a 16 anni che costringerà Cappello a rimanere paralizzato, non sarà mai un impedimento per il poeta friulano; uno dei più importanti insegnamenti legati al sogno come visione si interseca a questo evento traumatico dove il limite fisico diventa invece opportunità di pensiero, di bellezza e di sogno che non lascia spazio all’autocommiserazione.
Pierluigi Cappello ha creduto nel potere della poesia come strumento di consapevolezza e libertà, andando oltre il concreto ostacolo fisico che poneva una barriera fra lui e il mondo. Nella sua poesia e nella sua vita, nei suoi insegnamenti e nei suoi scritti, non si è mai piegato al pietismo ma ha sempre cercato la verità non spiritualizzando la sofferenza né rinnegando il suo corpo ma anzi, trasformando il dolore in parola poetica senza fronzoli. Il corpo diventa patria, in questo senso, e non limite: da lì partono il pensiero, la poesia, le percezioni, le memorie perché nonostante l’immobilità del fisico la mente e la parola restano, sempre, libere.
 '900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera
'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera