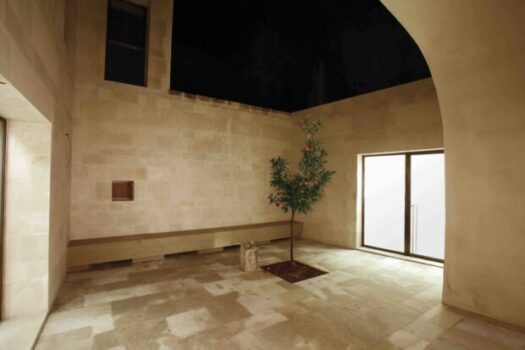La morte dell’Ambasciatore Attanasio svela il dramma del Congo, terra martoriata, un incubo lì da oltre un secolo. Ne hanno scritto, con varia intensità, in tanti: da Conrad a Conan Doyle, da Gide a Pietro Savorgnan di Brazzà, il fondatore di Brazzaville.
Il simbolo del Congo è l’Arcade du Cinquantenaire a Bruxelles. Commissionato da Leopoldo II nel 1880 per onorare i cinquant’anni dalla rivoluzione belga, fu realizzato nel 1905: trionfale è l’epiteto che gli calza a pennello. Che il simbolo dell’emancipazione del Belgio dal Regno Unito dei Paesi Bassi sia realizzato soggiogando uno dei paesi più ricchi dell’Africa oscura, è un paradosso crudele ed esemplare. “I profitti del Congo vennero usati per lanciare una grandiosa politica di opere pubbliche e di riqualificazione urbana. In Belgio, naturalmente. La magnifica Arcade du Cinquantenaire a Bruxelles, il famoso museo Tervuren, ampliamenti del palazzo reale, lavori pubblici a Ostenda, vari piani urbanistici: tutto fu finanziato dallo Stato libero del Congo” (John Reader, Africa. Biografia di un continente, Mondadori, 2001).
Se oggi in Congo si scava il coltan, allora era necessario per la gomma. Furono gli pneumatici a fare la fortuna di Leopoldo II, che si gettò in Congo con la fame dei re storditi dal tedio occidentale; razzia sistematica, ratificata dalla Conferenza di Berlino del 1884 nel sistema della laida spartizione europea del ‘continente nero’. Prima per le biciclette, poi per le automobili, gli pneumatici – brevettati da Edouard Michelin, maneggiati da John Dunlop, prodotti industrialmente da Charles Goodyear – mutarono la locomozione europea, le fortune di Leopoldo e i destini dello Stato Libero del Congo. Il lattice da cui si realizzava la gomma proveniva da alberi diffusi nelle foreste equatoriali: lo sfruttamento fu miliare, millimetrico, letale. Il Belgio cominciò a vendere concessioni, incassando; i civili furono cooptati in massa, violati, massacrati.
Il giornalista britannico Edmond Morel documentò come avveniva la ricerca degli alberi per la gomma. A chi non ricavava materiale sufficiente, venivano tagliate le mani. “Fa gelare il sangue vedere i soldati tornare con le mani degli uccisi, e trovare le mani di bambini piccoli fra quelle più grandi, prova della loro tracotanza… La gomma che viene da questo distretto è costata centinaia di vite e le scene cui ho assistito, senza poter far nulla per aiutare gli oppressi, sono state tali da farmi quasi desiderare di essere morto. Il traffico della gomma gronda sangue”, scrive Morel al “Times”.
Nel 1890, l’anno in cui scoppia il boom della gomma e Leopoldo II comincia a fare cassa, Joseph Conrad, a 32 anni, viene ingaggiato come capitano del “Roi des Belges”, un vaporetto che viaggia sul fiume Congo. Conrad era ormai un uomo fuori dal tempo, elegantemente inquieto: nel 1888 aveva compiuto l’ultimo grande viaggio tra Singapore, Australia, Mauritius; capitano di velieri, l’era dei grossi piroscafi lo tagliava fuori dagli ingaggi importanti. Tuttavia, voleva chiudere con l’Africa, che ancora manca nel suo giro del mondo in barca, che sogna. Nel frattempo, appunta Almayer’s Folly, il primo romanzo, che sarà pubblicato nel 1895. A smuovere la palude quotidiana sono i buoni uffici di Marguerite Poradowska, antica parente di Conrad, che abita a Bruxelles. La signora, da poco vedova, brillante, con il gusto per la scrittura, comincia a mobilitare il gran gala delle sue conoscenze: il 7 maggio del 1890 Conrad firma un contratto con la Société Anonyme Belge pour le Commerce de Haut-Congo; il 12 giugno parte da Bordeaux per Boma, il 2 agosto è a Kinshasa. Conrad deve sostituire, alla guida del vaporetto, sul magnetico Congo, un capitano belga, Johannes Freiesleben, ammazzato dagli indigeni. Si parla di una uccisione rituale, sviscerate le interiora, divorate le parti nobili, vitali.
Il viaggio non va secondo i piani di Conrad: dopo due mesi di comando del battello, tornato a Kinshasa, è affiancato e infine sostituito da un altro comandante, Alexandre Delcommune, belga. L’obbiettivo di Delcommune è svelato: invadere la regione del Katanga – che diventerà dominio belga nel 1891 –, strategica per i giacimenti minerari, prima che vi mettano piede i britannici. La presenza di Conrad, capitano con passaporto britannico, è di troppo.
È Conrad, più che altro, a capire di essere durato troppo: abbandona la nave, arma una canoa, rientra a Kinshasa, e da lì, dopo essersi preso la malaria, il 4 dicembre del 1890, rientra in Europa. Che Dag Hammarskjöld, segretario generale delle Nazioni Unite, sia morto in un misterioso incidente aereo il 18 settembre del 1961 proprio mentre si dirigeva in Katanga illividisce i segni, conferisce un ulteriore simbolismo al Congo, il cuore oscuro dell’uomo, il luogo in cui convergono enigmi, massacri, ruberie; l’inferno dell’Occidente in Africa, dove nessuno può dirsi innocente.
Intenso, audace, enigmatico, provocatorio, famoso – molti anni prima ha pubblicato L’immoralista e I sotterranei del Vaticano – André Gide fa un tour nell’Africa equatoriale francese nel 1925, da cui trae un libro, Voyage au Congo, edito da Gallimard due anni dopo. Gli avevano fatto credere di avere un incarico ministeriale, lo scrittore aveva 55 anni e passa parte del libro, in forma di diario, a raccontare la bellezza selvatica, aliena, primordiale dell’Africa. “Cielo indicibilmente puro. Mi pare che mai, in nessun luogo, ha potuto esserci un tempo più splendido. Mattinata molto fresca; si potrebbe credere di essere in Scozia”; “Ho raccolto sulla strada un minuscolo camaleonte e l’ho portato con me nella capanna dove sono rimasto a osservarlo per quasi un’ora. È veramente uno dei più straordinari animali della creazione”.
Il libro ha un fascino arcano: pare che Gide ripercorra a ritroso i primi giorni del mondo. L’esteta, tuttavia, non dimentica il polemista: l’estasi per gli indigeni (“Quel che non posso descrivere è la bellezza degli sguardi di questi indigeni… vicino a questi negri, quanti bianchi hanno l’aria di cafoni!”) non si tramuta in una secca condanna per il colonialismo, ma lo scrittore non si fa scrupoli – quando rientra dalla sua stregoneria retorica – nel descrivere le vessazioni, le ingiurie, gli sfruttamenti (che riguardano, però, ricorda, anche le tribù locali, in lotta per soggiogarsi a vicenda). Il libro – oggi candido e quasi pagano – fece rumore e i politici di Francia lo presero come un gesto antipatriottico, una sfida.
La prima tappa di Gide è a Brazzaville, che è ancora la capitale della Repubblica del Congo. “Strano paese dove si ha meno caldo di quanto si sudi. Andando a caccia di insetti sconosciuti, ritrovo felicità infantile”, scrive lo scrittore, futuro Nobel per la letteratura. Pietro Savorgnan di Brazzà, nato a Castel Gandolfo da nobili friulani, cresciuto nel Collegio romano retto dai gesuiti, cittadino francese dal 1874, aveva fondato Brazzaville dopo aver ottenuto la concessione di un vasto territorio da Makoko, capo temuto delle tribù locali. Non andava a caccia di insetti sconosciuti, non rimpiangeva l’infanzia, alla letteratura preferiva l’azione. In una celebre fotografia di Nadar, Savorgnan di Brazzà, eletto Commissario dell’Africa occidentale francese, indossa abiti locali, un vasto turbante mette in evidenza la barba scura e gli occhi, penetranti. È bellissimo; la profezia di Lawrence d’Arabia. In Congo si distinse per intraprendenza e compassione: gli indigeni apprezzavano i suoi modi, e per un po’ fu amato anche dai governatori di Francia. Nel 1879 rifiutò di prestare i suoi servigi a Leopoldo II; fu ostile a Henry Morton Stanley, foraggiato dal re del Belgio, rude nei modi. Amava l’Africa; molto meno le corti e i cortigiani in Parlamento.
Il grumo è tutto lì, in quella zolla di terra che dell’uomo riassume le violenze e i dolori, l’agonizzante, l’efferatezza, la vita ‘selvatica’, il sonnambulismo della ferocia, l’eccitazione politica. Una stregoneria mutila il Congo: dal massacro di Kindu del novembre 1961, in cui furono trucidati tredici aviatori italiani che lavoravano per le Nazioni Unite, all’assassinio dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere che lo proteggeva, è la stessa scia di follia scura, emblema del Congo-Idra depredato da troppi, dove mercenari e imprenditori, faccendieri, militari organizzati e avventurieri d’occasione si fondono nel crogiolo ideologico – islamici, maoisti, marxisti, sovietici, filoamericani, filocinesi, tutti sono passati di lì, sono ancora lì, in una guerriglia mai divenuta nostalgia. Tra l’omicidio di Patrice Lumumba – Primo ministro della Repubblica del Congo, vicino all’Urss – nel 1961, ritenuto un tassello della Guerra Fredda in Africa, a “The Rumble in The Jungle”, il leggendario incontro del 30 ottobre 1974 tra George Foreman e Muhammad Ali a Kinshasa, nell’allora Zaire di Mobutu, la storia è sempre la stessa, benché mutino registri e riflettori (in quel caso, da avanspettacolo all’americana, appropriato al mito, da divulgare in film). È sempre, cioè, la tattica coloniale condotta con altri mezzi ma con i medesimi scopi, elaborata tramite militari del luogo con supporto occidentale e spartizione, tra pochissimi, di vastissime risorse.
Durante il disastroso viaggio in Congo, Joseph Conrad appuntò un diario – scarno, pieno d’informazioni marinare, e di accenni ai soprusi lì osservati – che gli servì come schema per scrivere Cuore di tenebra. Nonostante la reazione di Chinua Achebe, che nel 1975 scrive un saggio al veleno, An Image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of Darkness, quel breve romanzo pubblicato sul “Blackwood’s Magazine” nel 1899, spina scura che ancora ci lacera l’iride, è la metafora perfetta del Congo. Semplicemente, Chinua Achebe è uno scrittore nigeriano che esordisce nel 1958, mentre Conrad è un uomo intriso di XIX secolo. Non è tanto per la polemica coloniale che va letto Cuore di tenebra – che pure balugina, nella milizia anonima di schiavi sfruttati dagli agenti occidentali avidi d’avorio:
“File di neri polverosi e dai piedi piatti arrivavano e partivano, un flusso di merci lavorate, cotonate di scarto, conterie, e filo di ottone andava a finire nelle profondità di quelle tenebre e in cambio ne tornava un prezioso gocciolio d’avorio” – ma per la visione disincantata, trasognata, torbida sull’essere umano, che setaccia gli spazi più disparati del mondo come fossero porzioni smangiate di uno stesso, demoniaco incubo. Sapeva, lo scrittore, di essere sceso nel “cuore delle tenebre”, in una catabasi geografica ed esistenziale, per fare speleologia nel cuore oscuro dell’uomo.
“La conquista della terra, che soprattutto significa toglierla a chi ha una carnagione diversa o un naso un po’ più schiacciato del nostro, non è una gran bella cosa… Ciò che la redime è soltanto l’idea… e una fede disinteressata a quell’idea – qualcosa che si possa innalzare e davanti alla quale ci si possa inchinare e alla quale offrire sacrifici…”, dice Marlow, raccontando il delirante viaggio in Congo, tra uomini tetragoni al feticcio del successo, di una libertà che procede ammazzando. Sembra di ascoltare Dostoevskij: tutta Europa inchinata al Baal del denaro, alla famelica avidità di fama, di sopruso, quasi che l’uomo si realizzasse soltanto soggiogando l’uomo. Del Congo, per altro, Conrad raccontò il magnetismo, il desiderio – anche questo ci strugge – di una vita ferina, improntata al selvatico, all’autentico. “Credetemi, nessuno ha mai pagato più caro di me le righe che ha scritto… Non sapevo che io godessi della crudeltà né che lo spargimento di sangue fosse la mia ossessione. Il fatto è che sono una persona assai più semplice”, scrive Conrad ad Arthur Symons, nel 1908.
E il Congo è lì, come il cuore oscuro estratto dal corpo di un dio, e fa luce, sinistra. Una leggenda Bantu, tramandata dai Bena Lulua, che abitano l’attuale Repubblica Democratica del Congo, fa dire a Fidi Mukullu, l’essere supremo:
“Io faccio gli uomini. Gli uomini fanno incantesimi, malattie, il coltello, il dardo, la guerra. Senza incantesimi, malattie, il coltello, il dardo, la guerra, la morte, senza tutto ciò la vita non è che mangiare, bere, dormire, digerire. La vita non è bella senza la morte”.
L’intellettuale dissidente