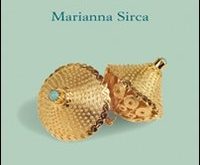Nonostante le note vicende sulla totale o parziale compromissione di Schmitt col regime nazista i suoi volumi sono sempre oggetto di approfondimento da parte delle università, anche americane dove, come racconta Andrea Mossa ne Il nemico ritrovato. Carl Schmitt e gli Stati Uniti (Accademia University Press, p.295), fecero per esempio carriera tanti ebrei tedeschi costretti all’esilio ma che con il suo pensiero e le opere avevano contratto consistenti debiti teorici. Impossibile quindi non confrontarsi, qualunque fosse il campo d’azione, filosofico, giuridico o politologico, con uno studioso che ha influenzato di molto la riflessione anche oltreoceano, sebbene le accademie di ogni ordine e grado scoraggino pur solo a menzionarne il nome.
Read More »‘Diario di un dolore’ di C. S. Lewis: la sofferenza per la perdita della persona amata e l’incomunicabilità verso ciò che è in noi
Le prime pagine di Diario di un dolore, sembrano quasi rievocare, accentuandone l’intensità lirica, gli ultimi versi di una poesia della Rossetti: Stripp’d bare of hope and everything, no more to laugh, no more to sing. I sit alone with sorrow. Ecco, I sit alone with sorrow, è l’immagine evocativa dello scritto. C. S. Lewis (autore del celebre fantasy Le cronache di Narnia, Sorpreso dalla gioia, Le due vie del pellegrino, A viso scoperto, I quattro amori, e primo propositore dell'argomento del desiderio come prova dell'esistenza di Dio) dopo la morte della moglie Joy, buttò giù una serie di note sparse, riflessioni e appunti, riordinate un anno dopo, e pubblicate sotto lo pseudonimo di N. W. Clerk, nel 1961.
Read More »‘Sulla felicità’ di Teilhard de Chardin: l’uomo deve incentrarsi su di se, decentrarsi sull’altro e supercentrarsi su qualcuno più grande di lui
Il breve saggio intitolato Sulla felicità del teologo, geologo e paleontologo gesuita francese Pierre Teilhard de Chardin è un testo "ardente" che risale al 1942 e tradotto in italiano per la prima volta nel 1970 in un volume che è difficile trovare in commercio: “Il Gesuita proibito – Vita ed opere di P. Teilhard de Chardin", Giancarlo Vigorelli (a cura di), Il Saggiatore. Secondo de Chardin, la felicità è inserire la propria vita nell'avventura del mondo, nella coniugazione di tre atteggiamenti fondamentali: creatività, amore, adorazione.
Read More »‘Gioventù perduta’, storia tipica del dopoguerra italiano, di Pietro Germi: un inizio travagliato tra scarti della Commissione del GUF di Genova e censura
Il primo impatto di Pietro Germi con il mondo del cinema è all’insegna dello scontro. Scartato dalla commissione del Guf di Genova, incaricata di effettuare una prima selezione di candidati ammissibili al concorso indetto dal Centro Sperimentale di Cinematografia, Branca Registi, non si dà per vinto e scrive una lunga lettera1 per protestare contro quel risultato a suo avviso sommamente ingiusto. Siamo nel 1937, Germi ha 23 anni e un bellicoso talento per l’esercizio dello sdegno, accompagnato da un’indole ribelle che il tempo potrà solo confermare. A dieci anni esatti da quella bocciatura, al “caso” del candidato Germi si aggiunge il “caso” Gioventù perduta, scatenato da un’altra lettera e destinato a rimanere unico, nella carriera del regista genovese, per il massiccio sostegno trasversale ottenuto anche – soprattutto – a sinistra, nel corso di una vera e propria campagna di stampa contro la censura. Portato a termine nell’autunno del 1947, il secondo lungometraggio di Germi ne è il protagonista indiscusso e forse ottiene il nulla osta, nel gennaio del 1948, anche grazie a questa imponente mobilitazione.
Read More »‘Una donna alla finestra’ di Drieu la Rochelle: un romanzo ambiguo sulla decadenza e un confronto con la Grecia metafisica
Una donna alla finestra di Pierre Drieu la Rochelle è un romanzo sulla decadenza e nella decadenza, scritto in un tempo magnifico e disgraziato nel quale i più grandi sogni degli uomini si sono trasformati nei loro peggiori incubi. Tre francesi, un italiano, più un tedesco, un persiano, un danese e un serbo. Sembra l’inizio di una barzelletta, invece è l’elenco dei personaggi che animano l’Atene cosmopolita degli anni Venti, sfondo e protagonista di Una donna alla finestra, appena riapparso nelle librerie italiane per le edizioni GOG. Un romanzo ambiguo, sottile, che si avvia nel banale schema di un ménage a trois, una donna sposata che si innamora di un altro uomo, sostenuta dall’alterno beneplacito del marito. Situazione strana e paradossale ma non troppo, se si considera che la donna è una giovane francese che ha sposato il marchese Rico Santorini, dell’ambasciata italiana, dandy latin lover e dissoluto ma non sprovveduto; mentre l’uomo al cui fascino crolla è Michel Boutros, comunista francese che una notte, scappando dalla polizia, si rifugia nella stanza d’albergo in cui alloggia proprio la bella Margot, che lo protegge e si fa complice della sua fuga.
Read More »‘Marianna Sirca’ di Grazia Deledda: una storia che brucia di passioni e che spezza le catene del pregiudizio
Marianna Sirca è un romanzo breve del 1915 di quella che è considerata la maestra del verismo romantico, ovvero Grazia Deledda, la cui opera venne subito apprezzata sia da Verga che da Capuana. La storia è incentrata su realtà storico/sociali del primo Novecento e ha per protagonista una giovane donna di origini umili, che diventa ricca grazie all'eredità di uno zio prete. Si innamora di Simone Sole un bandito nuorese povero ma dal carattere forte e deciso che deve saldare il proprio debito con la giustizia; i due decidono di sposarsi ma Marianna chiede a Simone di costituirsi e di scontare la sua pena. Quando tale segreto viene a galla, tutti sono contrari. La casa di Marianna Sirca è sorvegliata dai carabinieri ma Simone sparisce dalla circolazione per non farsi prendere e per non divenire oggetto di scherno da parte degli altri banditi.
Read More »La Suor Orsola Benincasa ricorda Giuseppe Galasso, padre del “Paesaggio come bene culturale”, scomparso ieri
Giuseppe Galasso si era affermato come storico dell’Età moderna, con grande attenzione anche al Medioevo e al Risorgimento. Aveva aderito al Partito Repubblicano di Ugo La Malfa e di Giovanni Spadolini, per il quale era stato deputato dal 1983 al 1994, ricoprendo due volte il ruolo di sottosegretario, prima ai Beni culturali e poi all’intervento straordinario nel Mezzogiorno. Per breve tempo era stato sindaco di Napoli e - dal 1978 al 1983 - Presidente della Biennale di Venezia. Aveva curato la riedizione delle opere di Croce per Adelphi, dirigeva la rivista «Acropoli» (Rubbettino), scriveva sul «Corriere». Inoltre era docente di Storia moderna all'università Suor Orsola Benincasa di Napoli e dal 1977 socio dell'Accademia dei Lincei.
Read More »Karl Kraus, aforista ironico e tagliente che non ha lesinato critiche alla società, ai politici e ai mass media del suo tempo
«Accidenti alla legge!»: con questo aforisma si potrebbe riassumere il carattere satirico, ironico e tagliente di Karl Kraus (Jičín, all’epoca parte dell’Impero asburgico, oggi della Repubblica Ceca), 28 aprile 1874 – Vienna, 12 giugno 1936), scrittore, aforista e giornalista che non ha lesinato critiche alla società, ai politici e ai mass media della sua epoca (rilevo, purtroppo, che abbiamo soltanto poche menti libere, ma soltanto scribacchini di infimo ordine).
Read More » '900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera
'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera