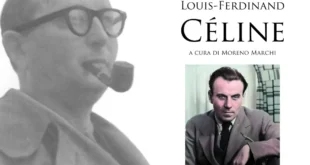Sviluppatosi tra il 1914 e il 1915 a Mosca e a Pietroburgo, il formalismo russo rappresenta un’importante ed influente scuola di critica letteraria, inizialmente coniato con intenti denigratori, in quanto volto ad indagare solo l’aspetto formale dell’opera letteraria, non avendo il linguaggio una funzione pratica. In questo senso la letteratura serve esclusivamente a mostrare le cose da un punto di vista diverso, senza badare al contenuto e alla dimensione metatestuale, anticipando cosi le istanze dello strutturalismo. Anzi, è l’artificio, la forma che genera il contenuto, ciò che rende letterario un testo non è la storia della cultura, ma il linguaggio.
I saggi “La Resurrezione della parola” di V. Šklovskij e “Dostoevskij e Gogol” di Rozanov e J. N. Tynjanov a gettare le basi della scuola futurista che rivendica la funzione creativa della parola che esprime concetti puri. Aspetto centrale della riflessione dei formalisti russi è la contrapposizione tra fabula ed intreccio, la prima indica la storia cosi come è avvenuta, rispettando l’ordine cronologico, l’intreccio, al contrario, è uno degli strumenti più importanti della letteratura e riorganizza la fabula, la rielabora attraverso descrizioni , digressioni, anticipazioni.
Si riscontrano quindi nei testi il protagonista che deve superare molte avversità, l’antagonista, la proibizione, la trasgressione, la conseguenziale punizione (colpa da espiare), l’estraniamento (concetto proprio di Tolstoj, quando gli avvenimenti non vengono chiamati con il loro nome ma è come se fossero visti e trattati per la prima volta) e di nuovo una trasgressione che porta ad una nuova punizione.
L’intreccio poi ha un “motivo”, come lo ha definito Tomashevsky, che può essere rappresentato da una singola azione; i motivi poi possono essere liberi e legati; i primi non sono essenziali ai fini della storia in sé, dovuti allo stile adottato dall’autore, mentre i secondi sono obbligatori, richiesti dalla storia.
Anche Propp nella sua “Morfologia della fiaba” si occupa della scissione tra fabula ed intreccio, definendo il concetto di Funzione in riferimento ai personaggi, ovvero l’operato, le azioni del personaggio definite dall’autore stesso. Si distinguono cosi degli elementi variabili, come le caratteristiche fisiche , psicologiche , le qualità morali, gli aspetti caratteriali, e quelli invariabili, ovvero la funzione del personaggio stesso. Propp individua 31 funzioni che saranno poi analizzate anche dal filologo e critico Cesare Segre (la famosa analisi della novella del Decameron di Boccaccio, “Lisabetta da Messina”).
Se Propp ha fatto valere l’esigenza di conoscere l’oggetto fiaba in sé attraverso la morfologia individuando un certo numero di funzioni e le relazioni, la scuola di Bachtin analizza la struttura linguistica dei testi letterari, soffermandosi sulla loro natura ideologica in quanto segni sociali opponendosi quindi a linguisti come Saussure e alla sua concezione astratta e sincronica della lingua. Secondo Bachtin poi tutto è dialogico, vista la pluralità dei significati.
 '900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera
'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera